
A.-J. Levine, Le parabole di Gesù. I racconti enigmatici di un rabbi controverso (Collana La Parola in altre parole 1), prefazione di G.L. Carrega, Effatà Editrice, Cantalupa (Torino) 2020, euro 18, pp. 379.
«Non è necessario venerare Gesù come Signore e Salvatore per dare un significato alle parabole. Le prime persone che le hanno ascoltate non lo adoravano. E tuttavia hanno prestato attenzione, perché le parabole parlano al cuore di chi ha orecchie per sentire e un po’ di pazienza per riflettere. Io non venero Gesù come Signore e Salvatore, ma continuo a tornare su queste storie perché sono al centro del mio ebraismo. Esse sfidano, provocano, condannano e allo stesso tempo divertono. Ogni volta che le leggo, anche quando penso di aver trovato una spiegazione per tutti i dettagli, so che qualcosa mi sfugge ancora, e devo ricominciare a leggerle. Le parabole mi hanno offerto ore e ore di ispirazione e conversazione. Sono perle di saggezza ebraica. Se le ascoltiamo nel loro contesto originale ed evitiamo le interpretazioni in chiave anti-ebraica che spesso le deformano, brillano di una luce che non può rimanere nascosta» (p. 376).
La parabola è una metafora allungata che mette assieme il mondo di Dio con il nostro, nel tentativo di creare una sorta di ponte, di comunicazione, tra noi e il Mistero che ci sovrasta. Svolge, tecnicamente, la funzione “a uncino”, di collegamento, attraverso un fatto inventato o semiserio e un evento reale, fino a creare un forte contrasto come termine di paragone. Anche Gesù fa uso di parabole secondo il metodo rabbinico del tempo e la forza di questi racconti è nell’iperbole, in un’esagerazione che permette all’uditorio di prendere posizione, di reagire, di interrogarsi sul senso di quello che è stato raccontato e messo a confronto. A volte, le parabole non hanno una conclusione, restano aperte nel loro movimento elicoidale, affinché la discussione continui. Ad esempio, nella parabola del padre buono che aveva due figli, o della famiglia sgangherata – non più semplicemente del “figliol prodigo”, che di prodigo non aveva quasi niente -, non si conosce il finale, non si sa se il figlio maggiore sia entrato a fare festa. Certi racconti ci lasciano con il “fiato sospeso”, con “il desiderio di…”, “sperando che…”. Tocca a noi, agli uditori, elaborare, immaginare, completare il racconto, prendere posizione, tirando fuori, però, quello che effettivamente abbiamo dentro: amore, perdono, misericordia, diritto di rivendicazione, senso di giustizia, o anche intransigenza, voglia di riscatto…
È oramai chiaro che una lettura moraleggiante delle parabole, così come pure della Bibbia, riduce il senso letterario della narrazione e toglie forza e vigore al racconto stesso che apre nuove piste di riflessioni, nuovi mondi spirituali e originali suggestioni sul rapporto con Dio e con il prossimo.
L’autrice di questo interessantissimo saggio sulle parabole raccontate da Gesù, se pur nella stesura redazionale finale degli evangelisti e dei precedenti sviluppi della tradizione orale, prova a rileggerle rimuovendo quegli elementi anti-giudaici che si sedimentarono nei secoli (dal cristianesimo delle origini fino a oggi) e riscoprendone il contesto giudaico nel quale erano collocate, favorendone una lettura non solo esistenziale ma pratico-spirituale, ossia sapienziale, avendo ben presente la questione sulla storicità delle parabole stesse e dell’insegnamento di Gesù. Il tentativo è di liberare le parabole di Gesù da un certo addomesticamento dei medesimi evangelisti: «con buona pace di Luca, le vicende della pecora smarrita e della moneta perduta non erano percepite originariamente come storie di pentimento e perdono. Né, penso, quella del figliol prodigo riguarda il pentimento, il perdono e in definitiva neppure il prodigo stesso» (p. 25).
Per Levine, le parabole non sono completamente allegoriche e non c’è sempre una corrispondenza diretta tra gli elementi di una parabola e quelli del mondo esterno: «un re può essere anche solo un re; un proprietario terriero qualcuno in cerca di operai; e una pecora smarrita non è vista immediatamente come un peccatore, pentito o incallito» (p. 29). Per questo, oggi, nel modo di interpretarle, si vive una certa atrofia uditiva che non permette di cogliere la provocazione del racconto di Gesù, e a volte si corre il pericolo di favorire gli stereotipi antisemiti del passato. Ad esempio, la parabola della pecorella smarrita più che narrare di un peccatore che ha perso la fede e adesso se ne pente, racconta di un pastore distratto «che si rende conto di aver perso qualcosa che per lui ha molto valore» (p. 59). Allo stesso modo, per la moneta perduta, la donna diviene responsabile dell’accaduto. Anche per la parabola del figliol prodigo, il protagonista è il padre che riesce a capire che cosa ha perso e vuole disperatamente ritrovarlo e, così, festeggiare (cf. p. 63). Le parabole non vanno spiegate con stereotipi negativi che favoriscono l’antigiudaismo: occorre, invece, contestualizzarle in ambienti propri, positivi, come nel caso della parabola del buon samaritano. I samaritani non sono semplicemente gli acerrimi nemici degli ebrei ma coloro che in 2Cr 28,8-15 ascoltano la voce del profeta, spezzando la spirale del male e della violenza (cf. p. 137). «Oggi la Samaria ha diversi nomi: Cisgiordania, Palestina occupata, Grande Israele. Per rendere attuale la parabola dobbiamo soltanto aggiornare l’identità dei personaggi. Sono un ebreo israeliano e mi trovo sulla strada da Gerusalemme a Gerico; sono attaccato dai ladri, picchiato e lasciato mezzo morto in un fosso» (pp. 140-141).
L’allegoria del lievito per indicare il regno dei cieli non è facile da comprendere se non si considera dal punto di vista culturale il significato del lievito (che può essere buono o cattivo) nella società del tempo e richiamandone i riferimenti scritturistici adeguati. Quel poco di lievito nella massa non vuole dire semplicemente che il regno dei cieli cresce misteriosamente da solo e per una propria efficacia o forza. Levine ricorda che anticamente si usava i lievito madre che era visibile e ingombrante. Il riferimento, allora, è altrove, alla giustizia, alla purità, al tempio come luogo supremo della purità e dell’offerta del pane lievitato. Il lievito non è impuro o sporco e rappresenta il cibo nella sua forma più completa e perfetta ed è immagine della grande pace, quella messianica (cf. p. 156). Conta l’azione che compie la donna nel mescolare il lievito, qualcosa di prezioso, con la farina: «qualsiasi cosa stia facendo la donna, il risultato verrà alla luce. Ciò che è nascosto lo è soltanto perché possa essere manifestato, e in quella rivelazione l’originale viene in qualche modo trasformato: i piccoli acquisiscono una conoscenza particolare, i discepoli una nuova prospettiva, i fedeli un nuovo modo di essere e il mondo più opere buone di quante ne siano mai esistite. “Nascondere”, come “lievito”, può avere una valenza negativa, ma in questa parabola si tratta di un nascondimento che porterà a qualcosa di meraviglioso» (p. 162).
L’intuizione di Levine è la seguente: spesso la parabola raccontata da Gesù è stata addomesticata dalla redazione finale dell’evangelista o dalle nostre inadeguate interpretazioni che non fanno emergere ciò che effettivamente Gesù voleva raccontare. È il caso della parabola delle dieci vergini che andrebbe intitolata «Lo sposo vergognosamente in ritardo» (p. 373). Lo sposo non è Gesù e non parla della sua seconda venuta. Forse, un’interpretazione non allegorica aiuta a collocare nel suo giusto contesto questa parabola: «Quando è giusto l’egoismo e quando no? Ci rallegriamo all’arrivo del pretendente o lo condanniamo per il suo ritardo?» (p. 374). Così, anche la parabola dei vignaioli omicidi potrebbe essere intesa come una critica a Dio che tarda a venire e che è assenteista (cf. p. 374). «Per l’evangelista, la parabola della vedova e del giudice riguarda la necessità di pregare sempre, non certo le donne che s’impongono in pubblico e tanto meno le minacce rivolte a chi non le ascolta, a prescindere dalla giustizia della loro richiesta. Per Luca, le parabole della pecora perduta, della moneta smarrita e dei figli perduti riguardano il pentimento e il perdono. In questo modo storie provocatorie, umoristiche e celebrative vengono banalizzate e ridotte ad affermazioni ovvie e scontate. Per Luca, la parabola del fariseo e del pubblicano rafforza l’idea dei cattivi farisei e dei bravi pubblicani, invece di mettere in discussione il significato della preghiera, delle buone azioni, del pentimento e della giustificazione […]. La parabola dell’uomo ricco e di Lazzaro non può riguardare il paradiso e l’inferno, perché questo potrebbe voler dire che le persone potevano essere salvate anche senza la croce o, al contrario, che la povertà e la sofferenza possono garantire un premio nell’aldilà a prescindere dalle buone azioni compiute» (p. 370).
La parabola del banchetto di nozze o del grande banchetto ci deve turbare profondamente perché richiama i temi della giustizia e del mal governo e della violenza più che farne una lettura morale a proposito dell’abito da indossare. La parabola del pubblicano e del fariseo che salgono a pregare al tempio non parla di umiltà e di giustificazione per grazia o per opere, ma semplicemente del fatto che entrambi furono giustificati: «Para seguito da accusativo può significare “a causa di” o “a vantaggio di”. Di conseguenza, l’ultima riga potrebbe essere intesa in questo senso: il pubblicano ha ricevuto la sua giustificazione a causa del fariseo […]. Senza la sentenza di Luca su chi si umilia e chi si innalza, la parabola dovrebbe concludersi in questo modo: “L’uomo tornò a casa giustificato accanto/insieme all’altro” o addirittura “a causa dell’altro”. Perché allora così tanti commentatori preferiscono trovare interpretazioni che portano a condannare i personaggi identificati con gli ebrei e il giudaismo? Le traduzioni “accanto a” e “a causa di” risultano più sensate nel contesto storico e suggeriscono anche la più grande provocazione della parabola. Il giudaismo è un movimento comunitario in cui le persone pregano al plurale […] e in cui ogni membro della comunità è responsabile dell’altro […]. Le buone azioni di una persona possono avere un impatto positivo sulle vite degli altri» (pp. 257-258). Non possiamo identificarci completamente né con il fariseo, che continuerà a comportarsi assai più rettamente di quanto farà la maggior parte della gente, né con il pubblicano in questo momento pentito, che forse continuerà a sbagliare. «Quando giudichiamo l’uno migliore dell’altro cadiamo nella trappola che ci tende la parabola. Questo però succede anche se rifiutiamo entrambe le figure, perché la maggior parte di noi non è né eccessivamente zelante come il fariseo, né peccatrice come il pubblicano» (p. 259).
Dalla parabola emerge qualcosa che non vogliamo accettare: «la grazia divina non può essere limitata, perché farlo equivarrebbe a limitare il divino stesso. Questa generosità illimitata è qualcosa di problematico per molti di noi. Siamo ben felici quando siamo noi a essere salvati, meno felici quando questa salvezza viene estesa a gente che non ci piace, specialmente quando la nostra avversione è sostenuta da ragioni apparentemente molto buone, del tipo: “È un peccatore”» (p. 259). Incalza sapientemente Levine: «Il tipo di generosità mostrata da un Dio che fa sorgere il sole sui buoni e suoi cattivi, il tipo di generosità che permette al pubblicano di attingere al pentimento collettivo del sistema del tempio e alle buone azioni del fariseo è quello che vogliamo per noi, ma che non vorremmo che gli altri ricevessero. E sappiamo bene, nel nostro intimo, che in questo caso il nostro senso di “giustizia” è limitato» (p. 260).
[Edoardo Scognamiglio].


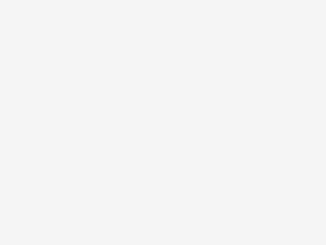

Commenta per primo