
H.F. Cipriani, Schiudi le mie labbra. Le vie della preghiera ebraica, prefazione di A.U. Piperno, Collana «Schulim Vogelmann» 212, Giuntina, Firenze 2018, pp. 421, euro 20.
Si può ritenere per vero, senza sbagliare, che la preghiera è uno dei pilastri di qualsiasi spiritualità e di ogni religione, anche dell’ebraismo. Alla domanda: «Perché un libro sulla preghiera ebraica?», l’autore stesso risponde così nell’introduzione: «La preghiera è solo uno dei diversi modi attraverso cui l’ebreo sviluppa la propria dimensione spirituale, conservandola in attività in modo analogo a quanto viene fatto per il corpo attraverso attività ginniche. Essa si accompagna al compimento delle mitsvòt, le responsabilità ebraiche, e allo studio, che è considerato la cosa più preziosa, come insegna il Talmud: “Lo studio della Torà vale tutte le mitsvòt (TB Kiddushìn 39b, 40a). La preghiera stessa però costituisce nell’ebraismo anche una forma di studio, di percorso antologico attraverso i principali testi della tradizione ebraica, il cui scopo è quello di preparare la persona all’incontro con la Trascendenza attraverso un excursus fra i concetti filosofici ed etici, oltre che i fatti storici […]. La preghiera ebraica comporta anche altri aspetti, come quello dell’incontro e del dialogo con il sé, una dimensione sottolineata dal fatto che il verbo pregare […] è un riflessivo, il cui significato letterale è quindi quello di pregare se stessi (ciò che la Trascendenza stessa fa, secondo TB Berakhot 7°), divenire se stessi preghiera oppure, se riconduciamo il termine alla radice p-l-l, autogiudicarsi […]. Inoltre, la preghiera ebraica non si concentra tanto su quelle che sono le nostre esigenze del momento, ma tende piuttosto a educare e sensibilizzare il fedele a quelle che dovrebbero essere le sue priorità» (pp. 11-12).
L’autore di questo saggio, la cui formazione rabbinica affonda le radici nelle tradizioni italiane e cassidiche, svolge il suo ministero in diverse comunità ebraiche francesi (a Marsiglia, Montpellier e Parigi) e in Italia (presso la comunità Etz Haim di cui è fondatore). Egli ha voluto qui raccogliere i commenti più importanti alla preghiera rabbinica, ponendo a confronto il senso del testo liturgico di una preghiera con l’ipertesto biblico che, in qualche modo, è presente in filigrana anche quando magari il passo è citato solo in piccola parte. «Il senso quindi si sprigiona dall’incontro che avviene nella mente del lettore fra i due contesti, spesso molto diversi, quello biblico originario e quello della dimensione liturgica in cui un determinato passo è usato. Tali contesti si rivelano spesso complementari, suggerendo nuove dimensioni di lettura sia del passo biblico che di quello liturgico» (p. 13). L’ebraismo rabbinico, che si costruì gradualmente verso la conclusione dell’epoca del Secondo Tempio e nei periodi successivi, nelle sue prime fasi pose l’accento soprattutto sulla dimensione normativa e sull’interpretazione dei testi biblici. Si tratta di due sfere nelle quali la letteratura rabbinica antica mostra un grande pluralismo di idee dovuto sia all’esistenza di scuole di pensiero piuttosto diversificate, sia alle influenze culturali provenienti da contesti estremamente vari, come quello babilonese e quello ellenistico. In tale condizioni, i maestri ebrei non elaborarono un apparato teologico sistematico e coerente e, di conseguenza, l’elaborazione di un sistema di preghiere comuni e vincolanti, rappresenta la prima espressione della teologia rabbinica classica. Si fa notare, poi, che il libro di preghiere, il siddùr, «non è mai stato un libro a contenuto fisso. Se la preghiera ebraica si è strutturata in modo coerente fra l’epoca del Secondo Tempio e quella talmudica, è evidente dallo studio delle fonti il fatto che è sempre esistita una certa fluidità nei testi recitati» (p. 13).
Dopo la prefazione (pp. 9-10), l’introduzione (pp. 11-16) e le riflessioni generali sulla preghiera ebraica (pp. 17-30), il presente saggio considera, in tre parti, le tre vie fondamentali della preghiera ebraica: la via dell’ascolto (pp. 31-208); la via della liberazione (pp. 209-386); la via della contemplazione (pp. 387-418). Segue una breve conclusione (pp. 419-421).
Pregare ogni giorno, secondo il grande saggio Maimonide, è una responsabilità affermativa della Torà, perché è “servire Dio” con tutto il cuore (cf. Dt 11,13). Il servizio del cuore è la preghiera che, per tradizione, non ha un orario fisso, né un numero preciso, almeno nelle sue prime formulazioni. È chiaro che, lodare e ringraziare Dio, supplicarlo e invocarlo, in un sistema oramai codificato, è un nostro bisogno in quanto corrisponde alla responsabilità religiosa o mitsvà: è un dovere e non un diritto, il cui scopo è «di liberarci da una situazione di possibile autarchia dello spirito, di ricordarci che tutto quel che abbiamo è un dono, e che molte cose ci sono affidate, ma nulla ci appartiene davvero» (pp. 17-18). Pregare, in un certo senso, è educarsi a una «forma di dipendenza, che talvolta può essere scomoda, ma che fa parte integrante della condizione umana» (p. 18). La visione di Maimonide, a proposito della preghiera, è messa in discussione dalla tradizione che fa capo a un altro grande maestro medievale, Nachmanide, secondo il quale l’idea della responsabilità nella preghiera sopraggiunge esclusivamente a momenti di angoscia, in cui il desiderio si pregare si manifesta spontaneamente. Evidentemente, si sono affermati, nel tempo, due modi di intendere la preghiera nel Talmud, «dove troviamo una tradizione secondo cui la preghiera sarebbe un’istituzione fondata dai patriarchi, e un’altra secondo la quale, invece, gli uffici quotidiani sarebbero nati come sostituzione dei sacrifici del Tempio. Tale differenza sembra alludere a due tipi di preghiera, quella spontanea, tipica dei patriarchi e di altri personaggi biblici, e quella formale e istituzionale» (p. 18).
Nella traduzione letterale di “servizio del cuore” (avodà shebalev), si fa notare che tale espressione può anche significare “lavoro del cuore”, giacché il termine avodà significa anche lavoro. «Si tratta di un lavoro non solo emotivo, ma intellettuale, perché nel pensiero antico il cuore era la sede di tutta l’attività mentale e della vita psichica della persona» (p. 18). Nelle fonti talmudiche si usa la parola tefillà per desinare la preghiera. La radice di tefillà non è semplice da comprendere. Una prima radice possibile è t-f-l che designa una cosa unita a un’altra, così come indicato in Pv 20,27: «la luce di Jhwh è l’anima dell’uomo». In tal senso, pregare significa unire la propria anima a Dio, nel senso che la propria anima è una parte del Trascendente, che come una fiamma tende verso l’elevazione. La tefillà è anelito verso la fonte della trascendenza, con cui l’orante cerca di mantenere una relazione costante. In tal senso, la preghiera è meditazione che armonizza i nostri sensi con la realtà che ci circonda (da qui il senso di TaFel, unito-integrato al resto dell’universo di cui abbiamo bisogno). La seconda radice possibile della parola tefillà è p-l-l, che significa “giudicare”. La preghiera è sempre un auto-giudizio, con riferimento a Gen 48,11, ove il vecchio Giacobbe, rivedendo dopo decenni il figlio Giuseppe creduto morto, dice: «Non pensavo/immaginavo/speravo [PiLlaLti] di vedere i tuoi volti». Si commenta così: «Il mio cuore non avrebbe mai potuto concepire il pensiero di rivedere ancora il tuo volto. PiLlaLti esprime il pernsiero» (p. 20). Si tratta di un “pensarsi” in base alle proprie azioni. Un altro riferimento biblico importante per la preghiera è Abramo, il patriarca che ha interceduto presso il Trascendente per ottenere che Sodoma sia risparmiata qualora un certo numero di giusti vi sia trovato (cf. Gen 18). Il termine amàd, da cui amidà, che designa la preghiera centrale del culto ebraico, è da intendere sia “lo stare in piedi” che “l’insistenza costante” nella preghiera rivolta a Dio.
Per i rabbini, la preghiera ha bisogno di norme ben precise ed è anche fonte di studio e di responsabilità e non può ma ridursi a una sorta di spiritualità evanescente: ci impone sempre di giudicare le nostre azioni verso gli altri.
[Edoardo Scognamiglio]


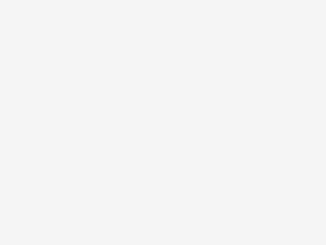
Commenta per primo