
I. Zilio-Grandi, Le virtù del buon musulmano, PBE 732, Einaudi, Torino 2020, pp. 178, euro 20.
“Essere buoni” o “fare del bene” (in arabo iḥsân), per un musulmano, esprime la «serenità del fedele di fronte all’istantanea Conoscenza delle sue azioni e intenzioni, l’occhio divino che osserva ogni cosa e ogni cosa giudica determinando la sorte di ognuno in questo mondo e nell’aldilà» (p. 4). Così, a pieno titolo, la bontà del fedele rientra negli atti di adorazione del vero credente che non è solo «chi testimonia, prega, digiuna, dona parte della sua ricchezza a favore della comunità, e compie il pellegrinaggio alla Mecca se è in grado di farlo; né è solo chi crede in Dio, negli angeli, nei libri celesti e nei profeti, nell’ultimo Giorno e in quel che Dio ha stabilito per le cose del mondo; ma è anche, necessariamente, una persona morale, benevolente e retta, di buon cuore e di buona coscienza» (p. 4). La bontà «non va affatto tenuta in subordine rispetto agli atti cultuali» (p. 4): è questo il leitmotiv del presente saggio che attinge molto dalla tradizione del Profeta per evidenziare lo stretto rapporto tra dimensione cultuale, istituzionale ed etica nell’islam. Le virtù e i valori del buon musulmano corrispondono spesso, con le dovute distinzioni, ai nomi che la Tradizione ha conferito a Dio sulla base della rivelazione coranica, e che sempre, secondo la Tradizione, Dio ama chi gli somiglia, ossia chi tenta di conformarsi ai suoi attributi e al suo comportamento (cf. p. 11).
«Scopo di questo libro, un breve compendio, certamente non esaustivo, delle principali virtù del buon musulmano, è illuminare l’elemento morale necessariamente sotteso alla religione islamica, e sottoporre al lettore i valori che questa religione veicola. La ricerca, spesso sostenuta dall’indagine lessicologica, muove da uno spoglio della letteratura religiosa in lingua araba, la principale lingua dell’islam, testi sapienziali o di tipo esegetico, teologico e giuridico, di epoca fondativa e classica e anche, dove possibile e opportuno, di epoca moderna e contemporanea; sembra, infatti, importante dare voce agli autori del nostro tempo, specialmente gli arabofoni il cui medium linguistico sottrae quasi sempre le loro opere a un’ampia diffusione […]. In secondo luogo, questo libro muove dalla volontà di controbattere alla percezione dell’islam nei paesi europei, sempre riduttiva, e di ricollocare la religione islamica al posto che le compete, cioè quello di una fede religiosa che, in quanto tale, esige il rispetto anche di chi non la condivide» (p. 13-14).
L’etica islamica delle virtù non è debitrice semplicemente dell’ethos greco, ma di una Tradizione propria che affonda le sue radici in autori e testimoni più svariati: «Oltre al Corano e alla sua esegesi, e oltre alla Sunna, un contributo all’etica islamica della virtù si trova in una letteratura che sta a mezza via tra la Tradizione propriamente detta e la narrativa; è una produzione di tipo sapienziale, che si nutre di detti profetici, massime, frammenti poetici e altro materiale aneddotico utile alla buona condotta e al giusto secondo religione, e come soddisfare convenzioni sociali» (p. 9-10). Tra gli autori più versati nel genere si fa riferimento di continuo a Ibn Abî al-Dunyâ (m. 281/894) di Baghdad: «tradizionalista, giurista, asceta, precettore di califfi e principi, contemporaneo dei massimi compilatori di Tradizione profetica, attivo in un clima cosmopolita e culturalmente vivace, gli si devono decine di opuscoli sui molti aspetti della vita morale: dalle virtù dell’intelletto all’utilità del pianto, dalla meditazione sui resti funerari alla bontà della gratitudine, dal buon comportamento nella malattia al biasimo delle bevande inebrianti, e molto altro» (p. 10).
Dopo l’introduzione, nella quale è presentato l’esempio altissimo di Allâh come modello divino che non ammette paragoni – ma che, per analogia, secondo alcuni pensatori musulmani, comunica le sue qualità divine al buon credente –, l’autrice indaga ben tredici interessanti e suggestivi lemmi che danno il nome ai rispettivi capitoli: Pazienza o costanza (pp. 15-28); Gratitudine e riconoscenza (pp. 29-40); Assennatezza (pp. 41-54); Misericordia o clemenza (pp. 55-68); Accoglienza e ospitalità (pp. 69-80); Il silenzio e le buone consuetudini della lingua (pp. 81-90); Modestia, pudicizia e reticenza (pp. 91-100); Bellezza (pp. 101-110); Pentimento e conversione (pp. 111-124); Tolleranza (pp. 125-134); Pace (pp. 135-142); Gentilezza (pp. 143-148); La cura degli animali (pp. 149-156). A seguire c’è una breve conclusione (p. 157), poi la bibliografia (pp. 159-176), l’indice delle virtù e delle qualità (pp. 177-178) e, in ultimo, l’indice dei termini arabi notevoli (p. 179).
È molto interessante il commento alla voce Misericordia in rapporto ai genitori e nell’ambito matrimoniale (con riferimento alla mansuetudine e alla pietà filiale e alla generosa compassione o benevolenza maritale per la decadenza fisica o la malattia del compagno o della moglie). Nel commento di Fakhr al-Dîn al-Râzî sulla benevolenza e la pietà, dà molto a pensare questa espressione: «L’amore concerne un bisogno personale, mentre la misericordia concerne il bisogno che gli altri hanno di noi. Mettiamo un uomo, che ama suo figlio, e che veda il proprio nemico nell’indigenza e nel patimento; quell’uomo potrà togliere al figlio e dare al nemico, ma lo farà per misericordia, non certo per amore» (p. 62). Se la misericordia lega coloro che credono, i quali possono ben dirsi confratelli (cf. p. 64), chi non ha misericordia neanche ne riceve, con riferimenti biblici molto chiari e diretti (cf. Gdc 2,13; Lc 6,36-38).
Pagine interessanti si riscontrano per descrivere l’ospitalità che è cara alla cultura araba, con paralleli biblici ben noti, a partire dalla storia di Abramo: la richiesta di ospitalità comporta un diritto di protezione e, in qualche modo, di annessione dell’ospite nella propria famiglia perché condivide cibo nella stessa casa (cf. pp. 72-75). «Nel pensiero coranico e islamico in genere, l’ospitalità si configura dunque e piuttosto apertamente come un atto cultuale giacché porta con sé l’avvicinamento di Dio e a Dio: in tal modo, il consenso all’avvicinamento dell’altro e specialmente dello sconosciuto assume i tratti di una sacra funzione in cui l’ospite è celebrato grazie alla condivisione del cibo. Ed è proprio quest’ultimo aspetto, il frazionamento e la distribuzione della sussistenza disponibile quale dovere religiosamente orientato, capace di produrre l’unificazione dei partecipi come fossero membri di un’unica famiglia, che si offre con forza alla coscienza di chi appartiene ad altre tradizioni culturali» (p. 79). Sul tema del pentimento e della conversione ci sono riferimenti biblici e approfondimenti che, dal punto di vista teologico e spirituale, ma altresì morale e psico-affettivo, sono molto suggestivi. Se il pentimento è già inizio di conversione, quest’atto avviene solo per benevolenza divina e consiste nel concedere all’uomo il successo nella sua stessa conversione, ossia nel ritorno alla vera fede. L’uomo si riconverte quando si ravvede e Dio si riconverte quando c’è il pentimento nel credente (cf. p. 112). Così, Dio torna sul servo quando questi ha fatto ritorno a lui dalla sua colpa. Anche il Profeta ha fatto esperienza di vera conversione, tanto da essere indicato come il Profeta della conversione o della misericordia, con riferimento al detto profetico: «L’adultero che compie adulterio non lo compie da credente, il ladro che ruba non ruba da credente, il bevitore che beve vino non lo beve da credente, perché in quel momento la fede lo abbandona; se si riconverte, Dio si riconverte a lui» (p. 1116). In realtà, è il ritorno di Dio a suscitare il ritorno umano (cf. pp. 116-117). L’insistenza sul ritorno e sulla conversione come caposaldo della religione islamica è oggi molto viva tra i predicatori come dimostra la pubblicazione del Libro della conversione dell’egiziano al-Sha‘râwî (cf. p. 122) in cui si rileva la strettissima connessione tra la moralità del credente e l’essere e il fare di Dio, ferma restando la divina incomparabilità, equiparando la clemenza divina alla gratuità dell’amore materno e all’apprensione di un padre.
Il capitolo decimo è dedicato alla Tolleranza che è definita come un caposaldo dell’etica islamica secondo il Corano e la Tradizione profetica (cf. p. 127-128), e prova a scardinare gli stereotipi sul carattere violento dell’islam dopo i fatti terroristici dell’11 settembre 2001. Approfondendo il lessico arabo sulla tolleranza, Zilio-Grandi fa notare che i termini arabi non contengono l’idea di sopportazione e non rimandano al patimento e alla sofferenza come accade, invece, nel latino tolerantia: «con il loro portato rimandano piuttosto al grande valore islamico della misericordia o clemenza, raḥma, quella volontà di bene che, si è visto, procede necessariamente dal maggiore al minore […]. La tolleranza dell’islam si nutre anche di bontà, nell’animo e nell’azione, quel che i musulmani d’ogni tempo chiamano iḥsân» (p. 126). Si fa poi riferimento alla reciprocità della tolleranza tra credenti e al Profeta come modello di tolleranza tra i compagni. Si tratta di una tolleranza pratica, spesso abbinata al coraggio e alla capacità di vivere e di adattarsi con semplicità. Dispiace non trovare, in queste pagine, accanto alle poche righe composte per descrivere l’intolleranza europea nei confronti dell’islam, il riconoscimento di alcuni atteggiamenti intolleranti assunti dallo stesso Profeta non riportati dalla letteratura fondativa per motivi apologetici ma che storicamente sono avvenuti. Una purificazione della memoria anche all’interno dell’islam aiuterebbe a scardinare pregiudizi e a superare stereotipi ben consolidati nel tempo a proposito della violenza del Profeta e dei suoi compagni, come altresì della violazione del diritto alla libertà religiosa delle minoranze anche e soprattutto nei Paesi a maggioranza musulmana, con buona pace di quelle istituzioni governative e di quei Paesi musulmani (come il Marocco) che da tempo si adoperano per il rispetto delle minoranze religiose sul proprio territorio.
Se Dio è gentile e ama la gentilezza (cf. pp. 143-1489), la cura degli animali rientra in questa tenerezza di Dio ben testimoniata dalla Tradizione. La sollecitudine verso gli animali domestici (e l’intero creato) è qui rivendicata come una priorità dell’islam rispetto a quanto si è sviluppato, in seguito, nella coscienza collettiva mondiale a proposito dei diritti degli animali e alla cura dell’ambiente (cf. pp. 149-155). I segni di Dio presenti nella creazione non danno il diritto di elaborare una concezione antropocentrica del mondo che assolutizza la libertà dell’uomo che può in tutto strumentalizzare la natura, ma rimettono, invece, tutto nel primato di Dio che è misericordia e bontà. Più che dominio sul creato o sulla natura, l’uomo ha da recuperare la sua responsabilità innanzi al mondo creato da Dio: è quanto il Corano e la Tradizione evidenziano da sempre e che la letteratura contemporanea musulmana ha ben focalizzato.
In definitiva, si è notato che molti dei valori etici sottesi all’opzione islamica «sono in sostanza già condivisi o del tutto condivisibili da chi appartenga a tradizioni religiose diverse, anche dietro qualche ombreggiatura particolare o qualche diversa sfumatura di senso dovuta alle immancabili specificità culturali: come la pazienza, che è più costanza, nel proposito e nell’azione; o la gratitudine, cosa concreta che richiede accrescimento; o la misericordia, volontà di bene che rimanda alla maternità; o la pace, che prima ancora è santità e salvezza; o il pentimento, che non porta con sé la pena ma il ritorno e il perdono» (p. 157).
[Edoardo Scognamiglio].



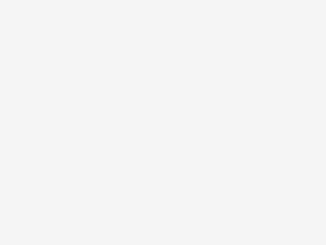
Commenta per primo