La
famiglia, il lavoro e la festa: tre doni da armonizzare
I risultati del Congresso
internazionale teologico-pastorale
Dal
30 maggio al 1 giugno 2012, si è svolto – a Milano – il Congresso
internazionale teologico-pastorale in occasione del VII incontro mondiale delle
famiglie. La famiglia: il lavoro e la
festa è stato il titolo del Convegno che ha visto partecipare più di
settemila persone. Un tema importante e significativo, come ha sottolineato
l’arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, nel saluto ufficiale: perché famiglia, lavoro e
festa legano tra loro gli aspetti principali della vita quotidiana d’ogni
persona. La famiglia, ha affermato il cardinale Scola, è la prima scuola di
comunione, il lavoro è l’ambito in cui si partecipa alla vita creatrice di Gesù. Tra
l’uno e l’altro s’inserisce il riposo, “spazio della rigenerazione”, che
diventa festa quando è un momento comunitario. Scola ha chiuso il suo
intervento ricordando le popolazioni terremotate. «Fra poco pregheremo per i morti di queste nuove scosse, per i
loro cari e le loro famiglie». Anche il cardinale Antonelli, presidente del
Pontificio Consiglio per la famiglia, ha ricordato i terremotati dell’Emilia:
«Siamo una grande assemblea riunita in un clima di fraternità e gioia. Ma aleggia
su di noi una nube di mestizia per il terremoto che ha colpito l’Emilia
Romagna. Ai morti, ai feriti, a chi ha perso casa e lavoro va il nostro
pensiero di solidarietà avvalorato dalla preghiera». Antonelli ha poi
evidenziato il carattere internazionale dell’evento e ne ha richiamato i
contenuti: «È un incontro mondiale perché le delegazioni provengono dai cinque
continenti, i partecipanti da centocinquanta paesi diversi […]. Il tema
dell’incontro mondiale, scelto dal santo padre Benedetto XVI, riguarda tre
valori umani, che la Sacra Scrittura, subito fin dall’inizio, presenta come tre
benedizioni di Dio. Tre benedizioni, dunque, collegate all’origine dell’uomo;
tre doni originari, fondanti, permanenti, essenziali per le persone e per la
società. Tre caratteristiche proprie della vita umana: solo l’uomo fa famiglia,
perché egli solo è capace di amare gratuitamente; solo l’uomo lavora, perché
egli solo è capace di ragionare, progettare, scegliere; solo l’uomo fa festa,
perché egli solo sa compiacersi per la bellezza dell’essere, del vivere, del
vivere insieme. Tre ambiti di comunicazione e di relazioni interumane, che
concorrono a definire l’identità delle persone e a costruire la loro felicità.
Tre dimensioni tra loro complementari e interdipendenti: la famiglia riceve
sostegno dal lavoro e il lavoro riceve capitale umano dalla famiglia; la
famiglia ha bisogno della festa per godere e intensificare la sua unità e la
festa ha bisogno della famiglia e della comunità, perché non si può far festa
da soli; il lavoro riceve motivazioni, energie e gioia dalla festa e la festa
suppone il lavoro e in certa misura sempre lo incorpora. La bellezza della vita
ordinaria, il benessere esistenziale e anche quello economico dipendono
dall’autenticità e dall’armonizzazione di questi tre ambiti della vita
personale e sociale. L’attuale crisi, che non è solo economica, ma anche
culturale, relazionale, religiosa, fa emergere un malessere che era latente da
tempo; acuisce il desiderio e la domanda di valori autentici; provoca alla
revisione delle dinamiche di mercato e degli stili di vita; invita a
riconoscere il primato della persona e della solidarietà, delle buone relazioni
e della collaborazione».
Il Congresso internazionale è stato suddiviso in tre
sessioni mattutine, con relazioni ufficiali, e in tavole rotonde pomeridiane
con brevi comunicazioni su diversi argomenti riguardanti il lavoro, la festa e
la famiglia. Ne riportiamo qui in sintesi i contenuti e gli aspetti più
importanti.
1. Tra opera della creazione e festa della
salvezza. La famiglia come un grande affresco così come sembra suggerire la
Scrittura, “tra opera della creazione e festa della salvezza”, l’ha immaginato
il cardinale Gianfranco Ravasi, biblista di fama mondiale e presidente del
Pontificio consiglio per la cultura, nell’intervento che ha aperto i lavori
della prima giornata del Congresso internazionale teologico-pastorale. Impreziosita da citazioni
letterarie e con diversi riferimenti all’attuale contesto socio-culturale, la
riflessione ha preso le mosse da una celebre affermazione fatta
dall’antropologo Claude Lévi-Strauss nel 1952: «La famiglia come unione più o
meno durevole, socialmente approvata, di un uomo, una donna e i loro figli è un
fenomeno universale, reperibile in ogni e qualunque tipo di società». Una
centralità della famiglia che tuttora permane: secondo un recente sondaggio, i
cittadini europei considerano fondamentale la famiglia e, in quarantasei Paesi
su quarantasette, la collocano al primo posto tra le realtà sociali più
importanti.
Prendendo come cifra
simbolica la “casa”, monsignor Ravasi ha indicato, anzitutto, le fondamenta
della famiglia nel rapporto di coppia, tra un uomo e donna «uguali nella loro
dignità radicale ma differenti nella loro identità individuale»: un’unità
d’amore che nel cristianesimo riceve “un suggello trascendente”.
Il rapporto uomo-donna è stato ben presentato da
mons. Ravasi attraverso l’analisi di sette parole, un corollario di perle,
presenti nel secondo capitolo della Genesi. La prima parola è ‘ezer, letteralmente un “aiuto” offerto
nel momento più critico e, quindi, diventa risolutivo e indispensabile. Nel
nostro caso c’è un incubo che sta attanagliando l’uomo appena uscito dalle mani
di Dio: è la solitudine-isolamento, che spegne quella vitalità ad extra strutturale per la persona.
«Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un ‘ezer che gli corrisponda», esclama, infatti, il Creatore (Gen 2,18). Come è noto, non è
sufficiente all’uomo avere accanto gli animali, che sono pure una simpatica
presenza nell’orizzonte terrestre: «l’uomo non trovò in essi un aiuto [‘ezer] che gli corrispondesse» (2,20).
L’uomo ha bisogno di un aiuto vivo e personale, un alleato nel quale egli possa
fissare gli occhi negli occhi, anche in un dialogo silenzioso perché – come
suggerisce un testo attribuito al grande Pascal – nella fede come nell’amore i
silenzi sono più eloquenti delle parole; nei due innamorati che si guardano
negli occhi in silenzio l’inesprimibile si fa esplicito, l’ineffabile si
rivela.
La seconda formula, ke-negdô, tradotta di solito con un “simile” o “corrispondente”
aiuto. In realtà, il suo significato di base suona letteralmente così: “come di
fronte”. È appunto quella parità di sguardi a cui s’accennava. Finora l’uomo ha
guardato verso l’alto, cioè verso la trascendenza, verso quel Dio che gli ha
infuso il respiro vitale, gli ha donato «la fiaccola» della coscienza che
«scruta le profondità dell’intimo» (Pr 20,27),
l’ha insignito della libertà, collocandolo all’ombra dell’«albero della
conoscenza del bene e del male». L’uomo ha poi guardato in basso, verso quegli
animali che rivolgevano a lui il loro muso in attesa di ricevere un nome (cf. Gen 2,19-20). Ora, invece, cerca un
volto davanti a sé, un “tu”, «il primo dei beni, un aiuto adatto a lui e una
colonna d’appoggio», come dice il Siracide (36,26), ma come meglio esclama la
donna del Cantico dei cantici, un essere con il quale è possibile comporre una
piena reciprocità di donazione: «Il mio amato è mio e io sono sua […]. Io sono
del mio amato e il mio amato è mio» (2,16; 6,3: l’originale ebraico è
musicalmente rimato e ritmato sul suono ô
e î che denotano i due pronomi
interpersonali, “lui” e “io” [dôdî lî
wa’anî lô… ’anî ledodî wedodî lî]).
Il terzo vocabolo è un simbolo. È quella “costola”
sulla quale si sono ricamate tante ironie antifemminili. L’intervento creativo
divino avviene all’interno di un “sonno”, che nella Bibbia è segno di
un’esperienza trascendente, è la sede delle rivelazioni e delle visioni, è
l’ambito in cui Dio è protagonista rispetto alla sua creatura. Ebbene, lo
svelamento del valore di quell’azione divina ha luogo al risveglio, quando
l’uomo intona quel canto d’amore primigenio che sarà declinato nella storia in
infinite forme e formule differenti: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne
dalla mia carne» (2,23). Carne e ossa sono le componenti strutturali del corpo
umano che, nell’antropologia biblica, è il segno della persona nella sua
pienezza comunicativa (non abbiamo un
corpo ma siamo un corpo). Si spiega,
così, il simbolo della “costola”: essa indica la piena parità strutturale e
costitutiva tra uomo e donna. Non per nulla, in sumerico ti designa sia la “costola” sia la “vita” trasmessa dalla donna. E
questo ci conduce spontaneamente al quarto termine che s’intreccia intimamente
con la quinta locuzione ed entrambi risuonano in Gen 2,24: «L’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno
un’unica carne». È evidente che
l’Adamo (in ebraico con l’articolo ha-’adam),
protagonista del passo, è l’uomo di tutti i tempi e di tutte le regioni del
nostro pianeta: egli con la sua donna dà origine a una nuova famiglia, definita
appunto attraverso i due vocaboli che ora sottolineiamo. Da un lato, c’è il
verbo dabaq (“unirsi”) che,
letteralmente, raffigura una stretta sintonia, un attaccamento fisico e
interiore, tant’è vero che lo si adotta persino per descrivere l’unione mistica
con Dio: «Il mio essere si tiene stretto [dabaq]
a te», canta l’orante del Sal 63,9.
Per questo, san Paolo afferma che «chi si unisce a una prostituta forma con
essa un solo corpo […] ma chi si unisce al Signore forma con lui un solo
spirito» (1Cor 6,16-17). Con il verbo
dabaq si ha, quindi, l’atto sessuale
sia nella sua dimensione corporea sia nella sua celebrazione d’amore, di
donazione totale della coppia. D’altro lato, ecco appunto la formula finale
“un’unica carne “ (basar ’ehad) che
definisce visivamente quel dabaq e
che apre il discorso forse alla componente successiva della “casa” che stiamo
innalzando: infatti, per l’esegeta tedesco Gerhard von Rad, l’“unica carne” è
anche il figlio che nascerà dai due e che porterà in sé, unendole, non solo
geneticamente, ma anche spiritualmente le due realtà dei suoi genitori.
Il disegno delle fondamenta della “casa-famiglia” si
completa con le ultime due parole: la donna «la si chiamerà ’isshah , perché da ’ish [l’uomo] è stata tratta» (2,23). Non c’è bisogno di spiegare
come l’autore sacro abbia voluto ricordarci che queste due persone che
costituiscono la coppia sono uguali nella loro dignità radicale, ma differenti
nella loro identità individuale: ’ish
è l’uomo nella sua realtà specifica e ’isshah
è lo stesso termine ma al femminile, svelando così come la donna e l’uomo siano
entrambi persone umane, pur nella diversità dei loro generi sessuali. La pienezza
dell’umanità è in questa uguaglianza fatta di reciprocità necessaria, dialogica
e complementare. La persona umana è, quindi, “duale” ed è così che realizza la
sua autentica “identità”.
A suggello, il cardinale Ravasi ha ripreso un
appello intenso del Talmud, la grande raccolta della tradizione religiosa
giudaica: «State molto attenti a far piangere una donna perché Dio conta le sue
lacrime! La donna è uscita dalla costola dell’uomo, non dai piedi perché
dovesse essere pestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per
essere uguale, un po’ più in basso del braccio per essere protetta, e dal lato
del cuore per essere amata». Nel cristianesimo, poi, questa unità d’amore
riceve un suggello trascendente ulteriore che l’apostolo Paolo chiama “mistero”
(Ef 5,32) e la teologia “sacramento”.
In modo illuminante il teologo martire del nazismo Dietrich Bonhoeffer così
commenterà questo trapasso: «Il matrimonio è più del vostro amore reciproco…
Finché siete voi soli ad amarvi, il vostro sguardo si limita nel riquadro
isolato della vostra coppia. Entrando nel matrimonio siete invece un anello
della catena di generazioni che Dio chiama al suo regno».
Ravasi
ha poi individuato nei figli le “pietre vive”. La pienezza della famiglia, ha
aggiunto, è affidata alla discendenza che può non essere solo biologica (come,
ad esempio, nell’adozione). «Dio è creatore, l’uomo e la donna sono generatori
e continuano la storia della salvezza». E ha ripreso, in proposito, una frase
di Giovanni Paolo II, pronunciata durante il viaggio apostolico in Messico nel
1979: «Il nostro Dio nel suo mistero più intimo non è una solitudine, ma una
famiglia […]. Così, il tema della famiglia non è affatto estraneo all’essenza
divina». La “casa-famiglia” (è questo il duplice significato del termine
biblico bet-bajit) è costituita di
stanze, la prima delle quali (“lo sguardo del credente deve essere realistico”,
ha chiosato Ravasi) è la “stanza del dolore”: «la Bibbia stessa ne è testimone
costante, a partire dalla brutale violenza fratricida di Caino su Abele e dalle
liti tra i figli e le spose degli stessi patriarchi», fino a Gesù che «conosce
le ansie e le tensioni delle famiglie travasandole nelle sue parabole»». Oggi –
ha continuato il cardinale – assistiamo a nuove lacerazioni del tessuto
familiare, un insieme di fenomeni socio-culturali che «scuote l’impianto
tradizionale della famiglia» e che rende la casa «un qualcosa di “liquido”». Di fronte a questi
fenomeni, la famiglia cristiana è chiamata a non rinchiudersi dietro le porte
blindate, perché «non è una monade ma la prima cellula della società» e questo
la carica di responsabilità.
La seconda stanza è quella del lavoro. Mons. Ravasi
ha rivisitato il significato biblico dell’impegno dell’uomo (Adamo ed Eva)
chiamato a custodire-coltivare la terra. Il lavoro è un dono divino, come
suggerisce il Sal 127: «Se il Signore
non vigila sulla città […] invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a
riposare, voi che mangiate un pane di fatica» (127,2). Ne è consapevole anche
la mater familias il cui ritratto
suggella il libro dei Proverbi, donna sapiente e fedele a Dio il cui lavoro è
celebrato in tutti i particolari quotidiani, così da attirarsi la lode del
marito e dei figli (cf. 31,10-31). Lo stesso apostolo Paolo sarà orgoglioso
dell’aver vissuto senza esser di peso a nessuno con l’opera delle sue mani,
tanto da imporre la regola ferrea: «Chi non lavora neppure mangi» (2Ts 3,7-12: cf. At 18,3).
Detto questo, si comprende che la disoccupazione e
la precarietà si trasformano in sofferenza, come si registra nel delicato ed
emozionante libretto di Rut e come ricorda Gesù nella parabola dei lavoratori a
giornata, seduti in ozio forzato nella piazza del villaggio (cf. Mt 20,1-16), o come egli sperimenta nel
fatto stesso di essere circondato spesso da miserabili e da affamati, così come
era accaduto al profeta Elia che si era trovato davanti una vedova col figlio
sfiniti dalla fame (cf. 1Re 17,7-18).
È ciò che la società contemporanea sta vivendo in modo talora tragico e questa
assenza di lavoro si trasforma in un vero e proprio attentato alla solidità
della “casa-famiglia”. Non bisogna neppure dimenticare la degenerazione che il
peccato introduce nella società, quando l’uomo si comporta da tiranno nei
confronti della natura, devastandola, sfruttandola egoisticamente e
brutalmente, secondo norme dispotiche, così da rendere il lavoro una cupa
alienazione, segnata dal sudore personale, dalla desertificazione del suolo
(cf. Gen 3,17-19) e dagli squilibri
economico-sociali contro i quali si leverà forte e chiara la denuncia costante
dei profeti, a cominciare da Elia (1Re 21)
e Amos per giungere fino allo stesso Gesù (ad es. Lc 12,13-21; 16,1-31). L’arricchimento sfrenato, fonte di
ingiustizie, è alla fine un’idolatria, come scriveva il teologo Paul Beauchamp,
nella sua opera La legge di Dio: «O
l’uomo adora Dio perché è Dio che lo ha fatto, o l’uomo adora l’idolo perché è
lui stesso ad averlo fatto. Io adoro colui che mi ha fatto o adoro colui che ho
fatto […]. L’idolatria colpisce il lavoro, come certe malattie colpiscono più
alcuni organi che altri».
Mons. Ravasi si è poi soffermato sulla terza stanza,
quella della festa e della gioia familiare. Essa, come suggeriva il filosofo
Soeren Kierkegaard, deve avere la porta che “si apre verso l’esterno così che può
essere richiusa solo andando fuori da se stessi”. E comunicare con l’esterno
può essere complesso e faticoso perché si presentano fenomeni inediti come la
globalizzazione, la civiltà digitale con la sua rete che avvolge il globo, il
fermento della scienza che non teme di inoltrarsi lungo sentieri d’altura come
nel caso delle neuroscienze e delle biotecnologie, l’incontro con volti diversi
e il cosiddetto “meticciato” delle culture e via elencando. Questa molteplicità
d’esperienze è, però, feconda e può arricchire la festa della famiglia, qualora
essa sappia custodire nel dialogo la sua identità cristiana in forma non
aggressiva e integralistica, ma sappia anche non stingersi e scolorirsi in un
generico e vago sincretismo. Bisogna, quindi, ricordare che l’ingresso in
questa stanza solare avviene non di rado dopo una lunga attesa e un’intensa
preparazione, come affermava in modo suggestivo nel suo Diario lo scrittore francese Jules Renard: “Se si vuol costruire la
casa della felicità, ci si deve ricordare che la stanza più grande dev’essere
la sala d’attesa”. Questo spazio gioioso è collegato e adiacente al locale del
lavoro.
«A questo proposito è significativo ancora una volta
il racconto d’apertura della creazione secondo la Genesi. In quella pagina
emerge un elemento simbolico dialettico che raccorda appunto lavoro e festa.
L’uomo è considerato il vertice della creazione: non è solo una realtà
“bella/buona” (tôb) come le altre
creature, ma è “molto bella/buona” (Gen 1,31).
Eppure egli è creato il sesto giorno e il sei, nella simbologia numerica
biblica, è indizio di imperfezione, essendo il sette il segno della pienezza.
L’uomo è, quindi, prigioniero del limite temporale, spaziale, fisico e
metafisico. Tuttavia, può evadere dal carcere della sua natura creaturale e
della stessa ferialità: lo fa quando celebra il sabato, il settimo giorno, la
festa, la liturgia, la preghiera. Quel giorno, infatti, è il tempo di Dio,
l’orizzonte trascendente in cui egli “riposa” nella pienezza della sua gloria.
Per questo, il sabato è tratteggiato dalla Genesi come un tempio che viene
“benedetto” e “consacrato”: “Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò”
(2,3), rendendolo la sede della vita piena e perfetta, il tempio nel tempo,
scandito dall’eternità. L’uomo e la donna, quando celebrano la liturgia
festiva, entrano nel tempio/tempo eterno divino. Come scriveva il pensatore
mistico ebreo Abraham J. Heschel nel suo noto testo sul Sabato (1951), “per sei giorni viviamo sotto la tirannia delle cose
dello spazio; il sabato ci mette in sintonia con la santità del tempo. In
questo giorno, siamo chiamati a partecipare a ciò che è eterno nel tempo, a
volgerci dai risultati della creazione al mistero della creazione, dal mondo
della creazione alla creazione del mondo”».
In questa linea è importante registrare nella
duplice redazione del Decalogo la diversa motivazione che giustifica la festa
sabbatica. Da un lato, in Dt 5,12-15
si sottolinea l’uscita dal regime del lavoro feriale, rievocando la liberazione
dall’alienazione dell’oppressiva schiavitù egizia; d’altro lato, in Es 20,8-11 si celebra l’ingresso nel
riposo perfetto ed eterno del settimo giorno “benedetto e consacrato” da Dio
dopo i sei giorni della creazione. La festa è, quindi, liberazione dal limite e
partecipazione all’eternità, è comunione con Dio che strappa la creatura umana
dal sesto giorno e la introduce nella festa del settimo ove essa “riposa” come
Dio. È per questo che la Lettera agli Ebrei dipinge la vita eterna come un
sabato senza fine, non più compresso dalla fuga del tempo né occupato dagli
idoli terreni o striato dal peccato umano (3,7-4,11). È per questo che
l’apocrifo giudaico Vita di Adamo ed Eva
afferma che «il settimo giorno è il segno della risurrezione e del mondo
futuro». È per questo che la festa primaria dell’Israele biblico, la pasqua, è
di sua natura familiare ed è collocata nello spazio della tenda domestica (Es 12): essa è la celebrazione
dell’uscita-esodo dal lavoro oppressivo imposto dal faraone ed è l’avvio
dell’ingresso nella terra promessa che diventa un simbolo della patria celeste,
come appare esplicitamente nella trama sia del Libro della Sapienza sia
dell’Apocalisse. È per questo che la celebrazione eucaristica delle origini
cristiane aveva come sede proprio la ecclesia
domestica e come contorno il convito familiare (cf. 1Cor 11,17-33). La festa autentica non è né un orizzonte vuoto e
inerte, come Tacito bollava il sabato degli Ebrei, né è un mero week-end, ma è
un evento positivo, è segno di una trascendenza resa disponibile alla creatura,
è dono di una comunione con Dio, è la requies
aeterna che i cristiani augurano ai loro defunti e che è già pregustata
nella liturgia terrena del “giorno del Signore”, la “domenica” (cf. Ap 1,10).
2. Uno
sguardo al mondo contemporaneo. Nella cultura dei consumi e della finanza che non
capendo più il lavoro non riesce a vivere neanche la festa, ha esordito il
professor Luigino Bruni, coordinatore del progetto di Economia di comunione, occorre tornare a rileggere la famiglia il
lavoro e la festa assieme, alla
luce di due parole-chiave – gratuità e dono – che, all’apparenza, sembrano
“totalmente altre” rispetto all’ambito economico.
La gratuità – ha spiegato
Bruni – è un’arte che si apprende in famiglia: «uno dei compiti tipici della
famiglia è proprio formare nelle persone l’etica del lavoro ben fatto
semplicemente perché le cose vanno fatte bene, perché esiste nelle cose una
vocazione che va rispettata in sé, anche quando nessuno mi vede, mi applaude,
mi punisce e mi premia». Spogliata da fraintendimenti indebiti, la gratuità «è
un modo di agire e uno stile di vita che consiste nell’accostarsi agli altri, a
se stesso, alla natura, alle cose, non per usarli utilitaristicamente, ma per
riconoscerli nella loro alterità, rispettarli e servirli ed entrare in rapporto
con loro». Non si tratta, però, di contrapporre il dono al mercato, la gratuità
al doveroso: «esistono, invece, delle grandi aeree di complementarietà: il
contratto può, e deve, sussidiare la reciprocità del dono»; è quanto avviene in
molte esperienze di economia sociale e civile, dal commercio equo e solidale
all’economia di comunione. “Gratuità” significa, dunque, riconoscere che un
comportamento va fatto perché è buono in sé, e non per la sua ricompensa o
sanzione esterni. Questa idea-guida ha evidenti ripercussioni tanto in seno
alla famiglia (no alla “paghetta” per i figli per non inquinare un rapporto che
deve rimanere gratuito) quanto nel mondo del lavoro. Il salario, nella proposta
di Bruni, va inteso come il giusto riconoscimento del lavoro svolto, ma non
deve mai diventare incentivo, pena trasformare il denaro nell’unica motivazione
del lavoro. È proprio questa una delle derive cui assistiamo oggi: «La cultura
economica capitalistica dominante» sta operando una rivoluzione silenziosa ma
di portata epocale su cui diciamo troppo poco anche come cristiani; il denaro è
diventato il principale o unico perché del lavorare.
All’estremo opposto «non
dobbiamo restare inermi e silenti di fronte a un sistema economico-politico che
remunera con stipendi milionari manager privati e pubblici, e lascia indigenti
maestre e infermieri. È una questione di giustizia, e quindi politica, etica e
spirituale». Ecco perché occorre
recuperare un’attenzione globale alla persona, in ogni ambito della vita.
L’economia e il lavoro debbono riconciliarsi anche con la festa, che «non è
capita dall’economia capitalistica per le stesse ragioni per le quali non
comprende il vero dono», essendo essenzialmente una faccenda di gratuità e di
relazioni. «Le famiglie sanno quali
grandi fallimenti produce un consumismo che riempie con le merci il vuoto dei
rapporti». Le relazioni umane sono spesso sostituite da gioco, lotterie,
alcool, televisione, cibo… Ecco perché è tempo – ha concluso Bruni – di
lanciare «una moratoria internazionale della pubblicità rivolta direttamente ai
bambini».
3. La famiglia come risorsa della società. La famiglia è una risorsa
per la società se non ci si allontana dal modello della coppia uomo-donna con i
loro figli. Lo afferma il professor Donati, riprendendo gli esiti di alcune
autorevoli ricerche appena pubblicate. La famiglia diventa soggetto di società
civile nella misura in cui produce beni relazionali, cioè risorse da
condividere con gli altri. Il professor Pierpaolo Donati, già presidente dell’Associazione italiana di
sociologia, è tra i principali studiosi italiani della famiglia. Ordinario di
Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Bologna,
Pierpaolo Donati è anche direttore dell’Osservatorio nazionale della famiglia.
Il professore ha presentato i risultati della ricerca commissionata dal
Pontificio Consiglio per la famiglia, confrontandosi con un campione di 3.500
persone. L’intento della ricerca è stato quello di andare a vedere quale forma
di famiglia sia più capace di dare un contributo di solidarietà, fiducia e
partecipazione attiva alla società, abbattendo il luogo comune secondo il quale
tutte le forme di famiglia sono “più o meno” equivalenti e tutte positive,
purché ci sia affetto. La verifica è stata fatta sul piano empirico con
un’analisi molto complessa di tutta la vita famigliare (vita di coppia,
relazioni genitori-figli, capitale sociale, rapporto famiglia-lavoro).
Si è potuto constatare che
la famiglia “normo-costituita” – come intesa dai sociologi –, composta cioè da
una coppia uomo-donna e dai loro figli, è la forma che costituisce la maggior
risorsa per la società. Quanto più la famiglia è ampia e stabile, tanto più
essa è percepita come soddisfacente dalle persone, che sentono di esserne
arricchite dal punto di vista umano. In queste famiglie esiste un circuito
virtuoso: quanto più la coppia è impegnata su un comune progetto di vita, tanto
più ha figli, i quali poi hanno più successo nella vita, sono cioè giovani che
si impegnano maggiormente, sia sul piano dello studio sia su quello
professionale, hanno condizioni di salute migliori, hanno comportamenti
pro-sociali. In generale, il benessere e la qualità di vita dell’intera
famiglia è migliore. Le altre forme familiari appaiono più deboli e precarie,
bisognose di assistenza e di aiuto, quindi, non sono risorse stesse vivendo
l’affettività nel gruppo ristretto, senza proiezioni verso la società. I figli
con un solo genitore presentano più problematiche sia sul piano dell’identità
relazionale sia nel rapporto con l’esterno. I figli unici, invece, di solito
fanno parte di famiglie benestanti, vedono alzare la soglia di conflittualità
interna e non sempre il benessere materiale li aiuta nel processo di
socializzazione. Le coppie con un solo figlio sono definite “restrittive”: si
chiudono in loro stesse.
Lo stato di salute delle
famiglie in Italia è critico. Perché le famiglie, come “risorsa”, sono una
minoranza: circa un terzo delle famiglie italiane. Un altro terzo è costituito
da famiglie che presentano varie forme di difficoltà e problemi seri, e l’altro
terzo è costituito da famiglie considerate “sfasciate”, con grandissima
instabilità e forme patologiche di relazioni. La coppia arriva al matrimonio in
età molto avanzata: trentatré anni per l’uomo e circa trentuno per la donna.
Così, crescono i conflitti interni e le separazioni: anche la crisi economica
ha contribuito all’aumento delle tensioni nella famiglia e a ritardare la
scelta del matrimonio. Se uno dovesse fare il bollettino dello stato di salute
della famiglia italiana dovrebbe dire che essa, in generale, non gode di ottima
salute, perché l’area delle famiglie “normali” si va riducendo anche per via
del calo dell’assistenza. Si tende a premiare il singolo come individuo, senza
tener conto della famiglia, istituzionalizzando così l’individualismo. Ci sono,
tuttavia, due modi di intendere questa tendenza. Secondo la prima
interpretazione, in senso positivo, si parla di emancipazione dell’individuo.
Si saluta come progresso la tendenza a intendere la famiglia come una forma di
convivenza quotidiana in cui i singoli definiscono liberamente i loro diritti e
doveri, affermandoli come scelte personali su cui solo loro possono decidere.
Si plaude alla famiglia come “invenzione del presente”. Si esalta la scelta di
chi vuole un figlio come segno di realizzazione individuale, senza per forza
formare la coppia genitoriale. Si approva la realizzazione del singolo. Si
additano come «nuove famiglie» le aggregazioni più disparate di individui che
sono alla ricerca di relazioni in cui sentirsi affettivamente a proprio agio.
Tutto ciò va sotto il nome di “pluralizzazione delle forme familiari”, nuova
frontiera sociale che viene salutata come la promessa di un mondo migliore in
cui ciascuno sarà più libero e uguale agli altri nel cercare la propria
felicità individuale. La famiglia è ridotta alle relazioni affettive primarie,
dimenticando che essa non è un semplice gruppo primario, ma è anche
un’istituzione sociale.
La seconda tesi sostiene,
invece, che l’individuo preso a sé è in un primo momento favorito, ma poi
subirà le ripercussioni negative della mancanza di reti sociali, di relazioni e
del capitale sociale della famiglia. Si va verso una società atomizzata in cui
l’individuo sarà più autonomo, ma anche più isolato e fragile. È un cambiamento
ambivalente: il distacco dalle relazioni emancipa, ma alla fine gli individui
senza famiglia, o con famiglie deboli e fragili, sono più problematici di
prima, e soffrono più spesso di tutta una serie di problemi o di patologie
psicologiche, come depressione, sconforto, senso di frustrazione, pessimismo,
mancanza di fiducia.
Sono in aumento le coppie che scelgono la convivenza.
Si tratta di un trend in crescita. Tuttavia, bisogna distinguere. Ci sono
coppie che si sentono costrette alla convivenza perché non riescono a mettere
su famiglia (il futuro è incerto) per il lavoro precario e la casa che non c’è.
Altre coppie, invece, scelgono la convivenza come stile di vita. Vige l’idea
che la famiglia si costituisca prima nella convivenza, con o senza figli, e che
poi maturi poco a poco. Quest’idea, però, non è suffragata dai fatti. Non è
dimostrato che le coppie che si sperimentano con un periodo anche lungo di
convivenza siano più felici, più solide, abbiano figli migliori. I dati dicono
che avviene il contrario. Non è dimostrato che le coppie che decidono di
convivere siano più stabili di quelle che hanno scelto il matrimonio come via
istituzionale. La coppia che non decide, che è incerta, che dice «vediamo come
va», è tendenzialmente narcisistica, chiusa in se stessa: dà il primato
all’affettività reciproca, al volersi bene tra i due, e questo non alimenta la
fiducia e la solidarietà verso la società. È un po’ un rinchiudersi in quella
che è la classica coppia romantica, di cui persiste lo stereotipo, il nido
caldo. Il panorama delle possibili «unioni» alternative alla
famiglia, tuttavia, è ampio e va allargandosi.
Da un recente rapporto del Centro internazionale studi
famiglia, che ha valutato la popolazione europea tra i 30 e i 55 anni di età che
vive in coppia, risulta che la differenza tra quella
che si chiama coppia «aggregativa» e coppia «generativa». L’aggregativa è
formata da individui che si mettono insieme e si sperimentano, si assaggiano a
vicenda, cercano di trovare un modus
vivendi affettivo di convivenza quotidiana. Tuttavia, rimangono degli
aggregati. La famiglia, invece, non è un aggregato, bensì è un fenomeno
emergente di natura relazionale, e solo quando è così genera dei figli e, in
generale, dà un valore sociale aggiunto alla società. È questa la coppia
generativa, ed è totalmente diversa, perché parte con l’idea della famiglia,
che non è semplice somma di individui, ma ha una sua progettualità generativa.
In sostanza, sono coppie che si vedono proiettate nel futuro, con figli, e quindi
che s’impegnano di più, che vedono la stabilità anche come una condizione
necessaria per avere figli ed educarli in un clima positivo e così via.
Noi certo abbiamo una cultura che va nella direzione
della pura e semplice aggregazione, per cui si dice che è famiglia qualsiasi
aggregato di individui che definiscono in modo del tutto soggettivo le loro
relazioni, diritti e obbligazioni, mettendo qualsiasi forma familiare sullo
stesso piano, perché tanto ciò che conta è “volersi bene”. Però, la condivisione
di vita progettuale è un’altra cosa, e in tutto questo la politica si è fatta
sempre più neutrale. Non offre orizzonti: si limita a recepire i cambiamenti
culturali della società che vengono dal mercato, diventato paradigma delle
relazioni. L’Europa vuole il mercato libero, non solo delle merci, ma anche
delle relazioni; ciascuno deve far famiglia come più gli aggrada: si tratta
d’una scelta privata considerata come una qualsiasi scelta personale di
mercato. La modernità come modello culturale fa leva sull’immunizzazione
dell’individuo dalle relazioni. Si sta erodendo l’idea che la famiglia sia un
bene comune. Si va, quindi, in una direzione miope, di maggior fragilità, che
farà anche comodo al mercato, ma in prospettiva fa il male della società. Certamente,
sarà difficile invertire la tendenza.
Ci sarà una reazione quando finalmente ci si renderà
conto che avere eroso le relazioni umane e sociali – come quelle familiari – ha
depauperato il capitale sociale, diminuito il capitale umano e la capacità delle
persone di essere all’altezza delle sfide culturali e tecnologiche,
dell’istruzione. Si reagirà quando ci si renderà conto che le relazioni contano
più delle cose materiali. La vera ricchezza è fatta di
relazioni sociali. Se creiamo reddito distruggendo la società, alla fine ci
perdiamo tutti. È il momento di fare un passo in più, congegnando interventi
politici che promuovano la solidarietà e la stabilità familiare, la fecondità,
la capacità di allevare i figli. In definitiva: se è vero che la famiglia “normo-costituita”
è risorsa per la società, allora è il caso che la politica promuova quel tipo
di famiglia, fatta salva ovviamente la libertà delle persone di vivere in un
altro modo, ma come scelta privata che la politica non ha l’obbligo di
favorire. Il principio è il seguente: quando è in gioco il welfare pubblico,
l’individuo deve essere sostenuto in relazione alla struttura famigliare di cui
si prende la responsabilità. E chi si assume più responsabilità, meglio sarà
trattato.
4. La prospettiva della fede. Il cardinale
Dionigi Tettamanzi ha offerto un’approfondita relazione a proposito della
famiglia e del lavoro in chiave teologica, ponendo attenzione al tema della
giustizia sociale e della solidarietà. Il punto di partenza è stato il testo di
Eb 12,12 che invita a tenere lo
sguardo fisso su Gesù autore e perfezionatore della fede. Il presule ha messo
in evidenza la dimensione familiare del lavoro umano, trovando nella famiglia
di Nazareth un modello molto concreto di fede e di lavoro, per superare una
visione utilitaristica della persona e delle sue capacità relazionali e
produttive. Si tratta di ricentrare in modo trinitario il nostro agire come
pure il nostro essere, ricollocando l’homo
faber nel giorno della festa o del sabato. Dopo aver richiamato i principi
basilari della dottrina sociale, il cardinale Tettamanzi si è soffermato
sull’enciclica Caritas in veritate di
Benedetto XVI, affermando che l’amore sarà sempre necessario, anche nella
società più giusta (cf. n. 28). Da qui l’esigenza di uno sviluppo umano
integrale: la società, infatti, sempre più globalizzata, ci rende vicini, ma
non ci rende fratelli (cf. n. 29). L’economia e la vita sociale devono essere plasmate dallo spirito del
dono, dalla logica del disinteresse, della comunione, della fraternità,
della solidarietà, della gratuità (cf. n. 38). La carità nella
verità pone l’uomo davanti alla stupefacente esperienza del dono. La
gratuità è presente nella sua vita in molteplici forme, spesso non riconosciute
a causa di una visione solo produttivistica e utilitaristica dell’esistente.
L’essere umano è fatto per il dono, che ne esprime e attua la dimensione di
trascendenza. Essendo dono di Dio assolutamente gratuito, la carità irrompe
nella nostra vita come qualcosa di non dovuto, che trascende ogni legge di giustizia.
Il dono, per sua natura, oltrepassa il merito: la sua regola è l’eccedenza.
Esso ci precede nella nostra stessa anima quale segno della presenza di Dio in
noi e della sua attesa nei nostri confronti. Perché dono ricevuto da tutti, la
carità nella verità è una forza che costituisce la comunità. Unifica gli uomini
secondo modalità in cui non ci sono barriere né confini.
L’unità del genere umano,
una comunione fraterna oltre ogni divisione, nasce dalla con-vocazione della
parola di Dio-Amore (cf. n. 34). La gratuità deve plasmare anche l’ambito
economico e sociale, e dunque tocca anche la famiglia e il lavoro. Certamente, la logica della gratuità
non implica che in economia si possa comprare e vendere gratis, senza
prezzo o senza corrispettivo; implica, invece, che si lavori e si
realizzino scambi e investimenti in
modo pienamente rispettoso dell’uomo,
quindi – non ultimi – dei suoi legami familiari e sociali! Gratuità
significa far sì che la persona umana
sia posta al vertice di ogni scelta economica, politica, sociale;
comporta che nessun essere umano sia
strumentalizzato ad altre logiche che non siano la piena realizzazione,
sua e dell’umanità intera! Una simile gratuità non può rimanere racchiusa in
alcuni ambiti dell’attività economica – quali ad esempio le associazioni, gli
enti con finalità mutualistica o cooperativa, i soggetti non profit in
genere –, quasi potessero esistere altri campi in cui l’unica regola è quella
del massimo profitto o del massimo tornaconto individuale! Viceversa, la
gratuità è dimensione vera e necessaria dell’intero agire sociale ed economico,
se intesa come dimensione qualitativa delle relazioni,
interpersonali e sociali. La gratuità
trova le sue sorgenti più vive e originali nella famiglia che, tramite il proprio lavoro, si configura come
luogo caratteristico in cui è quotidianamente possibile apprendere il linguaggio della gratuità!
La famiglia è il soggetto
esemplare in grado di praticare e di comunicare questo linguaggio
all’intera vita sociale, economica e politica: diviene così, prima e più che
ogni altro soggetto, la scuola di
socialità che educa alla gratuità tutti, compreso chi domani avrà
responsabilità in qualsiasi campo della vita sociale. Per questo, la famiglia
deve essere intesa non solo come ambiente affettivo in cui si vive la prossimità,
ma anche come vero e proprio punto
di partenza di una società rinnovata, capace di vivere la
gratuità nell’ambito di tutte le relazioni sociali! Si deve, tuttavia,
riconoscere che la piccola ma vera società qual è la famiglia, proprio nel lavoro –
come normale ma prezioso contributo allo sviluppo dell’intera vita sociale –, è sempre più minacciata. Nel suo sorgere,
anzitutto. Infatti, quando l’incertezza circa le condizioni di lavoro, in
conseguenza dei processi di mobilità e di deregolamentazione, diviene endemica,
ci si trova conseguentemente di fronte a forme d’instabilità psicologica, di
difficoltà a costruire propri percorsi coerenti nell’esistenza, compreso anche
quello verso il matrimonio. In tal senso, la precarietà strutturale,
in cui i giovani si trovano a vivere in molte parti del mondo, costituisce di
fatto una pesante ipoteca sul futuro delle famiglie e, di riflesso, della
società. Il che provoca un innegabile danno sotto il profilo economico, poiché
la crisi demografica si traduce anche in problema economico. Così, pure anche lungo l’intero arco di vita la famiglia si trova spesso minacciata e in profondità.
L’estromissione dal lavoro per lungo tempo, oppure la dipendenza prolungata
dall’assistenza pubblica o privata, minano la libertà e la creatività della
persona e i suoi rapporti familiari e sociali con forti sofferenze sul piano
psicologico e spirituale. In questa linea preoccupa gravemente la disoccupazione
giovanile, che secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro, nel suo
ultimo rapporto, è in crescita dell’80% nei Paesi sviluppati e di due terzi nei
Paesi emergenti: dati, questi, che interpellano con forza la società, in
particolare chi ha responsabilità politiche ed economiche.
Anche la povertà
minaccia pesantemente la vita di molte famiglie della terra, con il risultato
di una grave violazione della dignità
del lavoro umano. Pure lo sviluppo demografico non può
essere compromesso con il falso pretesto di considerarlo causa di povertà. È
necessario educarsi a vivere la crisi, la stessa precarietà, in un’ottica di
fede, provando a sviluppare una vera e propria spiritualità del lavoro e della
famiglia. Ed è qui che il cardinale Tettamanzi rifonda l’ethos del lavoro umano
nell’esperienza della famiglia di Nazareth. L’ethos della famiglia in
rapporto al lavoro si radica nel logos, ossia nella verità e nel senso
che Dio ha stampato nell’uomo e che questi è chiamato a conoscere e
riconoscere alla luce della ragione e della fede. È un ethos dinamico
che sollecita l’uomo a ordinarsi
liberamente e responsabilmente al telos, ossia al destino, alla mèta di
un compimento che è la gloria di Dio e la santità della persona umana. L’ethos, dunque, non è freno né
ostacolo, ma spinta a realizzare in modo sempre più pieno la vera umanità della
persona in se stessa e con gli altri. È sorgente di quelle virtù che
custodiscono e sviluppano i valori più alti di giustizia, solidarietà,
gratuità, generosità in ogni ambito della vita, in specie in quello della famiglia
e del lavoro.
Sono due, in particolare, i momenti etici fondamentali nella relazione
famiglia-lavoro. Il primo è
quello di favorire la “cultura” del
lavoro, la conoscenza adeguata e il cordiale “riconoscimento” dei valori
e delle esigenze – dei diritti e dei doveri – implicati nel rapporto
famiglia-lavoro. Il secondo è
la concreta assunzione di libertà
responsabile nel vivere le realtà della famiglia, del lavoro e della
loro reciproca implicazione. Questi due momenti etici sono sfidati oggi da diverse forme di complessità e di fragilità che coinvolgono, talvolta
drammaticamente, la realtà della famiglia e del lavoro, specie nel loro
vicendevole rapporto. Per questo si rende sempre più urgente un grande rilancio della
responsabilità educativa: da parte della famiglia, della scuola, della
società civile e della comunità cristiana. Come a dire che la prima questione posta dal lavoro oggi è
quella culturale, quella cioè del suo vero “senso” per la persona, la
famiglia, le comunità, la società.
A questo ethos, il cardinale Tettamanzi ha rivolto
rapide riflessioni riprendendo lo
sguardo rivolto a Cristo come “figlio del falegname” nella sua vita a
Nazareth, mettendo in evidenza la normalità del lavoro nella vita di Gesù ogni
giorno, come anche il sacrificio, la solidarietà e la fedeltà all’impegno nella
sua stessa famiglia.
La relazione si è conclusa
con due domande: “Senza lavoro, quale famiglia è possibile?”; “Senza famiglia,
quale lavoro è possibile?”. In realtà, non c’è famiglia senza lavoro!
Non è possibile costituirla o – se costituita – non è possibile farla crescere
nei valori e secondo le esigenze ad essa peculiari. La questione non è solo
economica, perché il lavoro è inserimento attivo nel tessuto della società, è
partecipazione responsabile all’edificazione della città: se esclusa, la
famiglia è come mutilata, emarginata, deturpata da una ferita che può portarla
a vergognarsi, a nascondersi, a prediligere sentieri male illuminati e
trascurare gli spazi aperti e luminosi in cui la gente si incontra, intesse
relazioni, entra in una vita di comunione. S’inserisce qui anche il fenomeno delle migrazioni
con i contraccolpi problematici o negativi, non solo sulla famiglia migrante
costretta a lasciare il proprio Paese, ma anche sul “lavoro temporaneo” specie
con l’attività di cura (badanti, colf, ecc.) di cui l’Europa è beneficiata
grazie, soprattutto, alla presenza di donne che provengono dalle Filippine, dal
Sudamerica, dall’Est e che hanno lasciato marito e figli pur di riuscire a
guadagnare il necessario. E il costo sociale di tutto questo non può non
interrogarci.
La risposta al secondo
interrogativo è la seguente: “Non c’è lavoro senza famiglia!”. L’esperienza, infatti, ci
dice che la famiglia è il luogo educativo primario anche
per il lavoro. Se manca un’adeguata educazione al lavoro, è ostacolata la
necessaria maturazione dei figli, con il rischio di non esporli al lavoro con
le sue difficoltà e di spingerli, comunque, al lavoro, anche se non corrisponde
alle reali situazioni dei figli o non ne valorizza le capacità o è scelto
esclusivamente per il reddito o la notorietà.
Obiettivo da raggiungere è
una conciliazione, meglio un’armonizzazione – un’alleanza positiva
– tra la vita di lavoro e
la vita di famiglia: nei ritmi di tempo (oggi sempre più frenetici) e nelle
condizioni di vita e di lavoro (si pensi al prolungarsi delle percorrenze per
recarsi sui luoghi di lavoro). Urge, allora, trovare strumenti adeguati
per migliorare il rapporto tra tempi della vita familiare e tempi del lavoro.
Una questione, questa, che investe soprattutto l’universo femminile,
che oggi porta il grosso del peso della cura dei figli: pensiamo ai contratti
part-time, ai congedi parentali e a tutte quelle forme che permettano una sana
flessibilità a tutela del lavoratore e della sua famiglia. È evidente che il
realizzarsi di una simile alleanza esige un’opera
insieme formativa e politico-sindacale: da un lato, chi lavora deve
essere educato a non “sacrificare” i valori più profondi della vita familiare
con un impegno lavorativo esclusivo e totalizzante, che non conosce né feste né
pause, che nega nei fatti ogni momento di riflessione, di vita familiare e di
dono di sé; dall’altro lato, chi è impegnato nella politica e nel sindacato
deve saper obbedire a logiche non solo di “efficienza economica”, ma anche di
“efficacia umana”, come la coltivazione di rapporti interpersonali più
significativi nell’ambito della famiglia e del più ampio tessuto sociale.
5. Opportunità e precarietà nella società urbana. La relazione di
Pedro Morandè Court, professore cileno, nell’introduzione, ha ripreso
un’affermazione di Giovanni Paolo II presente nella Lettera enciclica Centesimus annus: «La prima e
fondamentale struttura a favore dell’“ecologia umana” è la famiglia, in seno alla
quale l’uomo riceve le prime e determinanti nozioni intorno alla verità e al
bene, apprende che cosa vuol dire amare ed essere amati e, quindi, che cosa
vuol dire in concreto essere una persona. Si intende qui la famiglia fondata sul matrimonio, in
cui il dono reciproco di sé da parte dell’uomo e della donna crea un ambiente
di vita nel quale il bambino può nascere e sviluppare le sue potenzialità,
diventare consapevole della sua dignità e prepararsi ad affrontare il suo unico
e irripetibile destino» (n. 39). È qui sintetizzato in modo eccezionale ciò che
significa il lavoro per la famiglia. Da una parte, certamente procurare il
sostentamento materiale della vita, senza il quale non può esserci sviluppo
umano. Ma ancor più fondamentale è educare i figli nella verità e nel bene,
amarli in modo che possano scoprire la dignità con cui sono stati chiamati
all’esistenza dal Creatore, educarli alla conquista della loro libertà
interiore per affrontare umanamente il loro destino unico e irripetibile.
Tutta l’evidenza empirica,
oggi, rispetto all’educazione e all’origine delle disuguaglianze sociali,
indica che l’educazione dei bambini nei primi anni di vita è decisiva per il
loro sviluppo posteriore, generandosi precisamente in questa fase dello
sviluppo umano, la maggiore distanza sociale tra chi ha ricevuto attenzione,
accoglienza e stimoli emozionali nei confronti delle loro abilità cognitive e
chi non l’ha ricevuta. La scuola non è capace di correggere posteriormente ciò
che i genitori e la famiglia non hanno fatto a suo tempo. Per questo, la
relazione tra famiglia e lavoro non è estrinseca bensì intrinseca, non è un
peso che la società impone alle persone e alle famiglie, ma è piuttosto il
risultato della dignità co-creatrice che ha voluto dare agli esseri umani il
disegno divino sulla creazione.
Il magistero sociale della
Chiesa cattolica ci ha insegnato che tutta l’attività umana appartiene
all’ambito del lavoro. Non solo quella che è remunerata dalla società, ma anche
quella che si offre gratuitamente come un dono alle altre persone e alla
comunità a cui si appartiene. Tutte le persone lavorano sempre più di quanto
siano retribuite economicamente. Se questo vale per tutti gli ambiti della vita
sociale, a maggior ragione si applica alla famiglia, che gratuitamente ci
insegna molti aspetti essenziali della vita, come per esempio, a controllare il
nostro corpo, i suoi movimenti, il suo ritmo. Ci insegna anche il sempre
complesso linguaggio materno, con le differenze e sottigliezze tra la
fattualità degli eventi dell’attività umana e le ipotesi relative alla sua
possibilità passata e futura. In famiglia impariamo anche la moralità degli
atti umani e ad assumere la responsabilità rispetto alla dignità della nostra
condotta sia in relazione a noi stessi sia in relazione al prossimo. In essa,
impariamo a condividere anche la stima per la saggezza, per i beni spirituali
che abbiamo ricevuto come doni di chi ci ha preceduto nell’esistenza e, in
special modo, il dono della fede. Per tutto ciò, il magistero sociale della chiesa
ci ha insegnato che il lavoro non ha solo una dimensione oggettiva – perché
produce beni commerciabili e intercambiabili, che costruiscono il tessuto
sociale, tanto a livello locale, come regionale e mondiale –, ma anche una
dimensione soggettiva, non commerciabile, che costruisce la nostra propria
persona e che stimola la crescita della libertà per offrirsi agli altri, con
rispetto e dignità.
Il lavoro appartiene al
dinamismo della libertà e della creatività umana per mezzo delle quali
trasformiamo il mondo per soddisfare le necessità delle persone. Senza questa
soddisfazione non potrebbe esserci una convivenza pacifica e giusta tra i
popoli. Tuttavia questa soddisfazione dei bisogni non si ottiene solamente
attraverso l’acquisizione di beni di consumo commerciabili. Certamente, per la
maggior parte delle persone, il lavoro remunerato è la principale fonte delle
loro entrate per sostenere se stessi e la propria famiglia. Ciò nonostante, il
lavoro eccede la sua retribuzione per l’amore con cui si realizza, per la
libertà che si mette in gioco, per l’innovazione e la creatività che propone.
Il lavoro è la risposta effettiva che gli esseri umani danno al dono della vita
e a tutti gli altri doni che ricevono dai loro antenati, dai loro progenitori,
dalle loro famiglie, dai loro maestri. È un elemento essenziale della reciprocità
dei vincoli sociali a partire dai quali si produce una convivenza pacifica tra
le persone, si genera fiducia, desideri di cooperazione e aiuto reciproco. In
una parola, il lavoro aiuta le persone a scoprire la propria vita come
vocazione, come quell’esortazione che ricevono dagli altri a sviluppare i loro
talenti, le loro virtù, la pienezza della loro libertà.
La società post-industriale
ha cambiato quasi completamente il significato del lavoro e la sua relazione
con la famiglia. Anche se l’espressione non è completamente soddisfacente, la
famiglia si è trasformata in un fattore essenziale nella formazione del
“capitale umano”, minando il suo significato originario. Il secondo fattore
sociale della nostra epoca è stato l’inserimento della donna nel mercato del
lavoro remunerato.
Questa è stata la
rivoluzione sociale più importante del XX secolo. Si tratta di un processo
ancora in corso, con importanti ritardi nei Paesi emergenti e nei Paesi
sottosviluppati, dove mancano ancora grandi inversioni nell’ambito educativo.
Con tutto ciò, sembra essere un processo irreversibile che ha cambiato
sostanzialmente le relazioni del lavoro e anche il volto degli spazi pubblici
della società. Inizialmente, si sono creati posti per lavori femminili. Invece,
nel suo decorso, l’incorporazione della donna al mercato del lavoro comprende
già tutti gli ambiti sociali, inclusi quelli che prima erano tipicamente
maschili, come le miniere, le costruzioni, la ricerca scientifica, le forze
armate, la polizia e molti altri. Anche nell’esercizio del potere politico le
donne hanno mostrato abilità e talenti che permettono loro di competere
vantaggiosamente con gli uomini.
L’ingresso della donna nel
mondo del lavoro salariato non ha significato solamente un riconoscimento del
valore sociale della condizione femminile come tale, piuttosto ha significato
una profonda ridefinizione dei ruoli sociali influendo sulla società nel suo
insieme. Innanzitutto, ha aiutato
alla crescita economica potendo la società disporre di un maggior numero di
risorse umane qualificate e di maggior varietà di specializzazioni. La donna ha
qualità naturali e abilità sociali che non necessariamente devono competere con
quelle maschili, quanto piuttosto completarle. Le aziende, da parte loro, hanno
dovuto organizzarsi e disporre di servizi che prima non avevano. Le leggi
sociali hanno dovuto riconoscere l’estensione per maternità per la donna, e
anche per la cura dei figli minori d’età quando si ammalano. Si sono dovuti creare
asili nido nei luoghi di lavoro secondo determinate condizioni, istituire il
lavoro part time e aumentare la
flessibilità lavorativa. Giuridicamente si è dovuto riconoscere la capacità
delle donne per amministrare i beni e, nel caso delle donne sposate, per
amministrarli con i rispettivi coniugi.
Per la famiglia, un secondo
stipendio ha significato il rafforzamento del suo potere d’acquisto e la sua
capacità di investire, che non sempre ha significato anche un maggior consumo,
ma anche un risparmio e inversione. La situazione di questo aspetto è molto
distinta nelle differenti regioni del mondo conformemente al grado di sviluppo
sociale dei paesi. Ciò nonostante, in generale, possiamo affermare che ha
aiutato alla progressiva scomparsa del proletariato e all’incremento dei ceti
medi con aspettative di mobilità sociale ascendente. Le famiglie cominciano a
spendere meno in alimenti e di più in dotazioni per la casa, particolarmente di
alta tecnologia, e anche in automobili, in vacanze, viaggi e uso del tempo
libero.
D’altra parte, però, le
donne hanno dovuto assumere, almeno durante un periodo di transizione che
ancora non è terminato, il doppio lavoro della loro professione e dei lavori
domestici. La ridefinizione dei ruoli all’interno della famiglia non è stata
semplice. Gli uomini hanno dovuto assumere, almeno parzialmente, lavori
domestici, occupandosi della cura e della salute dei figli e della loro
educazione. Abituati a essere gli unici sostenitori della famiglia, si sono
dovuti abituare all’idea che le loro coniugi possono avere entrate superiori ai
propri o assumere incarichi di leadership e di responsabilità di gerarchia
superiore, e questo ha ferito, a volte, la loro auto stima. Tuttavia, la cosa
più importante è stato il dover accettare che le loro mogli sono economicamente
autosufficienti e che l’antica dipendenza dalla casa deve essere rieducata, riconoscendo
e valorizzando la loro libertà di esercitare la propria professione o mestiere
e per realizzare il proprio progetto di vita.
Le opportunità introdotte
nella famiglia da questa ridefinizione dei ruoli ha una relazione essenzialmente
con la qualità della vita, non solo materiale, ma anche spirituale. Per le
coppie sposate ha significato un approfondimento della loro relazione di
reciprocità e complementarietà, comprendendo che i talenti di entrambi devono
condividersi in una vita costruita quotidianamente in comune. Per i padri, ha
significato anche un avvicinamento alla realtà dei figli, preoccupandosi della
loro cura e della loro educazione: ciò ha sviluppato un vincolo emozionale
normalmente sconosciuto in precedenza. Questi cambiamenti, però, hanno portato anche nuovi rischi che hanno
mostrato la precarietà della vita matrimoniale. In primo luogo, hanno fatto del
matrimonio una relazione più personalizzata e, quindi molto più esigente, con
la conseguenza di una maggior frequenza di rotture matrimoniali quando le
relazioni sono immature e unilaterali. Se si produce una rottura della
convivenza, nella maggior parte dei casi la tutela dei figli è affidata alla
madre, generando, così, in essi, l’esperienza del “padre assente”, che è
diventata una vera cultura nella nostra epoca. I figli educati in assenza di
padre, a loro volta, rimangono infantili e immaturi, retro-alimentando il
circolo delle rotture matrimoniali, specialmente, in età giovane e con pochi
anni di convivenza. Tutti i fattori menzionati sono strettamente vincolati e si
rafforzano tra sé, in modo tale che i matrimoni e le famiglie
dovranno imparare a controllare i rischi di rottura della convivenza
accentuando la donazione reciproca, la fiducia nella vocazione umana di ogni
membro della famiglia, il rispetto della dignità inalienabile di tutti i membri
e la qualità spirituale della cultura che vanno forgiando in comune. Forse, però, il rischio più
importante per il matrimonio e la famiglia è la pratica dei metodi
anticoncezionali attualmente in uso, tanto preventivi come i così chiamati
“metodi di emergenza”, che lasciano la decisione della concezione
unilateralmente in mano alla donna. Infine, nel caso del continente
latinoamericano, si deve considerare l’alta proporzione dei figli nati fuori
del matrimonio. Anche se non si conoscono ancora tutti i fattori in gioco,
questo si spiega, in parte, grazie alla tradizione storica di una società nata
originalmente dall’incrocio di razze, in parte, dalla diminuzione dei matrimoni
e dall’incremento del divorzio tra coloro che l’hanno celebrato. La convivenza
consensuale degli uomini e delle donne che non contraggono matrimonio sta
diventando una pratica abituale, specialmente tra i giovani e la società ha
smesso di considerare questa condotta negativamente piuttosto l’ha legittimata.
La relazione tra famiglia e
lavoro nell’attualità richiede un nuovo orizzonte culturale. Non si tratta più
di ottenere le entrate necessarie per la sopravvivenza e lo sviluppo, sia
attraverso il tradizionale padre provvidente o, oggi, delle varie entrate
apportate dai membri della famiglia, specialmente le donne che lavorano. Non è
neanche sufficiente la relazione emozionale di attaccamento e riconoscimento di
appartenenza a un tessuto sociale costruito quotidianamente dalla relazione
quotidiana faccia a faccia dei diversi membri della famiglia. Ancora più
insufficiente risulta, tuttavia, la ristrettezza demografica prodotta dalla
riduzione delle famiglie e dalla riduzione risultante dei vincoli di parentela.
Bisogna riscoprire l’immagine della famiglia come chiesa domestica perché in
essa si realizza la profondità del senso della comunione ecclesiale.
Segnaliamo, tra le tavole
rotonde del pomeriggio, quella che ha trattato de Il lavoro nella società urbana e la famiglia. Gian Carlo Blangiardo, demografo, Hong-Soon Han,
ambasciatore della Corea presso la Santa Sede, e suor Alessandra Smerilli,
economista, hanno messo a fuoco il rapporto e il ruolo della famiglia nella
città. Nelle società del nostro tempo il valore della famiglia trova un
riconoscimento indiscusso e universale. L’ha dimostrato con i dati di alcune
indagini Gian Carlo Blangiardo,
docente di Demografia e direttore del Dipartimento di statistica
dell’Università di Milano-Bicocca, intervenuto in un’altra delle sessioni di
lavoro del pomeriggio. La famiglia, “alla prova dei fatti”, è costretta a
cedere terreno nelle grandi scelte del ciclo di vita – come quella di sposarsi
o far nascere un figlio – spesso filtrate da valutazioni di ordine economico e
lavorativo. Bisogna prendere atto d’una grande verità di fatto: i progetti di
formazione e di sviluppo delle famiglie si scontrano con una realtà sociale che
ha fortemente bisogno di capitale umano, ma fa ben poco per sostenere la
fabbrica in cui tale capitale è prodotto e formato. Occorre recuperare la
“centralità della famiglia”: è questa l’unica strategia per restituire alle
società urbane quella vitalità demografica da cui non può prescindere ogni
progetto di sviluppo, doverosamente rispettoso del ruolo e del valore
dell’uomo.
Per l’ambasciatore della Corea presso la Santa Sede, Thomas Hong-Soon Han, è necessario che
la società intervenga con politiche adeguate a favore della famiglia; certo,
anche la famiglia deve coinvolgersi per proteggere se stessa attraverso la
partecipazione più attiva alla politica familiare. Questo perché
l’urbanizzazione e la globalizzazione stanno portando alla trasformazione
radicale della struttura del lavoro e, al contempo, alla trasformazione della
fisionomia della famiglia nella società urbana. Il diplomatico ha notato che la
femminilizzazione della forza lavoro, in combinazione con l’informatizzazione
del lavoro, rendono le donne più autonome e i ruoli e le relazioni tra i sessi
subiscono un notevole cambiamento e così anche il concetto di matrimonio: i
casi di divorzio aumentano.
“Riportare il femminile nei
luoghi di lavoro”: è questo l’argomento trattato dall’economista suor Alessandra Smerilli, la quale ha
notato che l’economia moderna ha espulso la gratuità, sviluppando l’idea che il
contratto è un buon sostituto del dono e che riportare il femminile nei luoghi
di lavoro li renderebbe più umani. Dagli studi emerge, infatti, come in media
le donne sono più avverse al rischio, abilità fondamentale per evitare i
fallimenti, e si è visto che esse sono più abili nel cooperare in gruppo per
risolvere i problemi.
6. La festa: tra antropologia e interculturalità. La professoressa
Blanca Castilla, docente di Antropologia filosofica all’Istituto Giovanni Paolo
II di Madrid, ha inaugurato la terza sessione del Congresso internazionale
teologico-pastorale riflettendo sul rapporto esistente tra famiglia, festa e
fede. Ha concluso la sessione il cardinale Sean O’Malley che ci ha invitati a
riflettere sul bisogno di santificare la festa come famiglia: l’eucaristia è il
nostro respiro; senza la domenica, dunque, non possiamo vivere! Senza
l’eucaristia domenicale perdiamo la nostra identità e viene meno la forza di
annunciare al mondo la buona novella del Cristo morto e risorto. La metafora
della vite e dei tralci ci fa comprendere che senza il legame vitale con il
Cristo – pane di vita – non possiamo avere alcun futuro.
Merita attenzione la comunicazione
di mons. Barthélemy Adoukonou (del Benin) segretario del Pontificio Consiglio
della cultura a proposito de La famiglia
e la festa nella diversità delle culture. Per superare una visione
strettamente solipsistica della persona, il cui modello ha radici nel logos
occidentale, mons. Adoukonou ha invitato a riscoprire il concetto di “immagine
e somiglianza” come proprium del modo
d’essere e d’esistere di ogni persona. Ciò permette di superare anche una certa
ideologia culturale che è nata con il secolo dei lumi. Il tema della festa, nella
tradizione africana, è radicato all’interno della famiglia che, in un orizzonte
semantico più vasto, è definita “parentela”. Nella cultura africana
tradizionale, si riconosce la dipendenza filiale come prima relazione costitutiva
dell’identità della famiglia. Prima della relazione sponsale c’è la filiazione.
Questa è la presa di coscienza che l’identità viene da un altro. L’identità si
declina da fuori ed è di origine divina e si esprime nella dipendenza filiale
fino alla figura ancestrale più importante. Attorno a questa relazione
fondamentale della filiazione, che rappresenta un indice antropologico maggiore
della coscienza dell’essere creatura, si articolano le altre relazioni che
costituiscono la famiglia: la relazione sponsale, la paternità-maternità
derivata e la fraternità.
La
prima festa della parentela è il memoriale ancestrale. La memoria dell’antenato
eponimo riunisce ogni anno tutta la discendenza per le grandi benedizioni.
La
seconda festa è quella dell’alleanza matrimoniale che unisce due famiglie.
La
terza festa è quella dell’uscita del bambino. Qui la famiglia africana celebra
la filiazione.
È
molto importante il canto della gloria del bambino nella tradizione africana aja-fon: «E tê wê nyi Ie? O vi wé nyi le (bis). A na gba singbo bo gba gan.
Adimêvî jen ka nyi le.. bo d’ajo mê, le. O vi we nyi le [Che cosa è il
beneficio della vita? È il bambino che ha il beneficio della vita. Tu puoi
costruire case grandi con più piani e coprirle con un grande tetto, ma solo il
bimbo beneficia del commercio della vita. Oh, si, il bambino è lui il guadagno
più prezioso della vita]».
La
quarta festa è rappresentata dai funerali. Questi segnano la fine della vita e
l’entrata nell’aldilà. Le società africane festeggiano generalmente in più
tappe l’uomo che ha avuto una vita esemplare in questo mondo e lo beatificano
nella comunità familiare. Le diverse forme di celebrazione al cuore della
parentela, oggi, costituiscono per le famiglie cristiane momenti
d’interpellanza e anche luoghi di prova per la fede. Quale sarebbe la
situazione della famiglia oggi in Africa? Gli africani sono sottomessi a un
doppio rito per i loro figli (nella parentela e nella chiesa); un doppio rito
di matrimonio (nella parentela e nella chiesa) e una doppia commemorazione dei
defunti (nella parentela e nella chiesa).
Una
soluzione pastorale consiste nel vietare alle famiglie cristiane i riti della
parentela. Questo ha condotto certe persone a un sincretismo dissimulato (nella
chiesa di giorno e nella parentela di notte). Altri, invece, cercano di
rifiutare i riti familiari con il rischio di tagliare le relazioni con la
parentela. Le celebrazioni sono riprese in forme nuove nelle grandi città. I
battesimi dei bambini, la prima comunione, la cresima, il matrimonio e
soprattutto i funerali sono seguiti da una grande celebrazione profana, dove
tutti gli eccessi sono permessi: lo spreco dei beni, l’ubriacarsi,
l’inquinamento sonoro di giorno e di notte.
Nell’orizzonte
della parentela, la festa più importante della famiglia – come istituzione
fraternale nella coscienza filiale dell’uomo che non è all’origine di se stesso
– è il memoriale ancestrale. Tutta la parentela si ritrova nella memoria del
fondatore, l’antenato, che nella bella definizione di Senghor è “la più antica
figura di Dio”. Qui la festa si rivela nella sua natura profonda come
partecipazione alla comunione fraterna che si riceve da fuori. Niente andrà
storto in una festa di questo genere. Al contrario, le alleanze sono rafforzate
in un codice che possa mantenere la discendenza in un’etica alta e che fa
percepire chiaramente che si devono seguire le “leggi che regolano la vita” (gbèsu) e lasciar perdere gli artifici
del mago/stregone. Quando saltiamo la chiave di referenza parentale sotto
l’influenza individualista della famiglia, anche cristiana, si distrugge il
cerchio della parentela e s’indeboliscono le alleanze forti che lo mantengono.
Si partecipa alla strumentalizzazione politica delle strutture di parentela
tradizionale e si va verso il mago/stregone da una parte e, dall’altra, si
libera uno spazio di festa senza limiti per la famiglia, un momento di
eccessività che, in realtà, ferisce l’ethos
umano in Africa. Si vendono terreni per pagare le feste dopo i funerali, si
svuotano i granai e si espone tutta la discendenza alla fame! Queste
considerazioni veloci sulla famiglia e la festa nella diversità delle culture
hanno dimostrato che all’orizzonte della parentela o della famiglia allargata
che si trova in Africa, la famiglia si risveglia con la benedizione; si tratta
d’una benedizione che ci fa pensare alla benedizione biblica rivolta ad Abramo
e alla sua discendenza. Festeggiare, per la famiglia cristiana, che è icona
della chiesa, famiglia di Dio, significa oramai ritrovare tutto questo campo
grande della vita che non si può limitare all’orizzonte nucleare
individualistico. Occorre andare nello spazio della famiglia allargata che è
anch’essa un’analogia della famiglia umana intera.
7. Tre dimensioni e benedizioni del vivere.
La conclusione della plenaria del Congresso teologico-pastorale è stata
affidata al cardinale Ennio Antonelli che ha voluto offrire uno sguardo
panoramico sulle tre sessioni plenarie e sulle ben venticinque tavole rotonde
pomeridiane dedicate ad eventi e incontri. Secondo il presidente del Pontificio
Consiglio per la famiglia, il Congresso ha messo insieme riflessioni di
carattere dottrinale, testimonianze di esperienze concrete e indagini
statistiche, seguendo un unico filo rosso: la famiglia come risorsa. È
auspicabile tradurre in un linguaggio accessibile a tutti i risultati del
Congresso. Il tema del lavoro e della festa è stato affrontato in chiave
antropologica, insieme alla lettura teologica della famiglia. Certamente, la
famiglia, il lavoro e la festa sono tre beni – tre doni – indispensabili a ogni
uomo e richiamano l’amore trinitario di Dio che è Padre, Figlio e Spirito
Santo. È emerso chiaramente che la famiglia, il lavoro e la festa subiscono
riduzioni non indifferenti nella nostra società. La famiglia si riduce a pura
coabitazione. Il lavoro, in un mercato violento, diventa merce di scambio: la
speculazione finanziaria prevale sull’economia del dono. La festa tende a
perdere il suo significato sociale e familiare e si riduce a puro divertimento.
Occorre aprirsi al bene, al bello, alla verità, per scoprire l’economia del
dono e della solidarietà. Solo così la famiglia, il lavoro e la festa potranno
trovare la loro armonizzazione. Per superare la crisi è necessario realizzare
una rivoluzione culturale e ricollocare al centro il ruolo e l’identità della
famiglia per il bene del mondo e della società. Il contributo più specifico
delle famiglie al sistema economico e sociale è la produzione del capitale
umano. Il fattore produttivo e decisivo è l’uomo stesso, che non è soltanto
soggetto di consumo e di risparmio, bensì soggetto produttivo di capitale
umano. La famiglia è la prima scuola di lavoro ed è amica delle imprese. Una società che non si occupa della famiglia è una
società che va contro se stessa. Perciò, la famiglia ha bisogno di essere
sostenuta con un disegno politico organico che tenga conto dei problemi
economici, del lavoro, dell’abitazione, dei fattori culturali e relazionali dei
membri stessi della famiglia. Le imprese, da parte loro, dovrebbero diventare più
amiche delle famiglie, anche per loro interesse: la mancanza di lavoro è un
dramma, specialmente per i giovani, e svilisce la formazione delle persone per
il mondo lavorativo. Inoltre, le imprese dovrebbero favorire il più possibile
l’armonizzazione tra esigenze lavorative e quelle familiari.
«Occorre allargare la
visione dell’uomo da individuo a persona, cioè soggetto spirituale e coporeo,
autocosciente e libero, singolare e irripetibile, relazionale e
auto-trascendente, chiamato ad amare gli altri come se stesso, a integrare l’eros nell’agape, a realizzarsi pienamente nel dono di sé agli altri e a Dio.
Bisogna tenersi aperti al vero, al bene e al bello senza chiudersi nell’utile
[…]. Tutte le dimensioni della vita devono essere plasmate dall’amore. Non solo
nella famiglia e nella festa, ma anche nel lavoro e nell’economia deve
prevalere la logica del dono, integrando utilità e gratuità, bene strumentale e
bene voluto per se stesso. “Senza la gratuità – scrive Benedetto XVI – non si
riesce a realizzare nemmeno la giustizia” (Caritas
in veritate, n. 38) […]. Solo curando la qualità delle relazioni e
restituendo il primato all’amore e alla comunione, la famiglia, il lavoro e la
festa potranno ritrovare la loro autenticità e armonizzazione. Per superare la
crisi, sembra necessario, a livello globale, una rivoluzione culturale,
antropologica, prima che economica».
Edoardo Scognamiglio

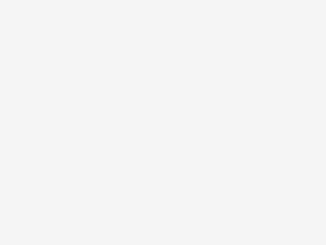
Commenta per primo